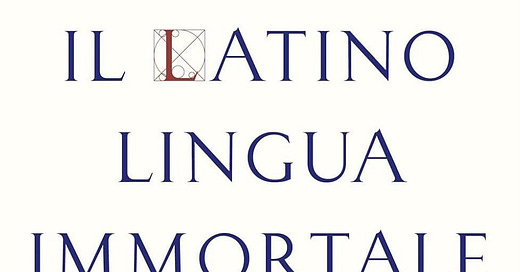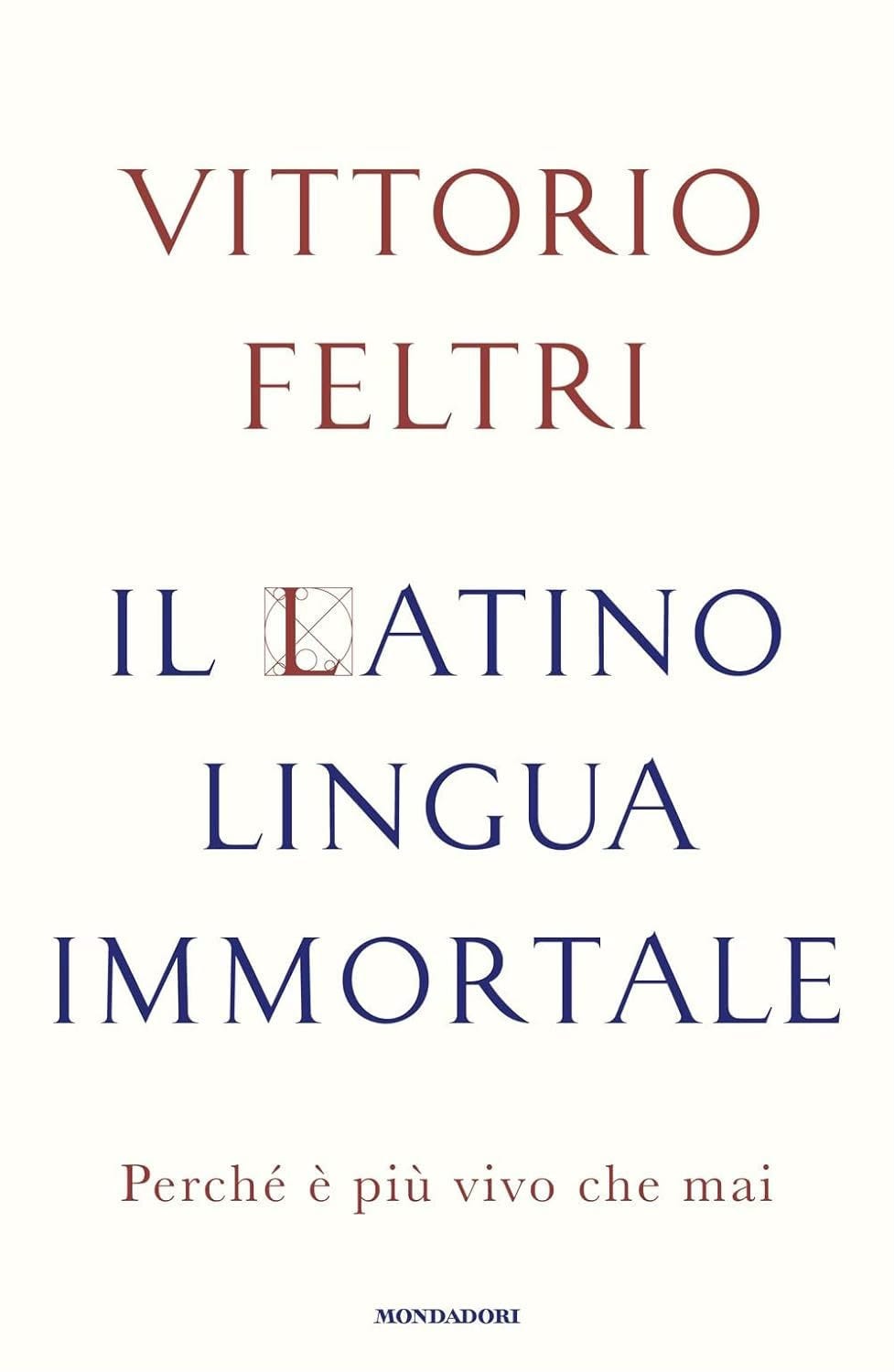Col passare del tempo, diventiamo tutti drammaticamente simili alla nostra caricatura. Vittorio Feltri lo sa e saggiamente definisce l’imitazione di Crozza il suo alter ego, chiarendo che “di solito mi fa ridere, la trovo divertente”, anche se lo dipinge “come uno che non riesce a esprimersi se non usando sempre e comunque il turpiloquio”. Per i famosi e famosissimi, come Feltri, le caricature tendono a somigliare ai “santini” degli ammiratori: il turpiloquio è l’altra faccia della prosa diretta e ruvida per cui Feltri, che si è disegnato addosso un personaggio televisivo alla ispettore Callaghan, è noto. Il “feltrismo” è stato un giornalismo di stile aggressivo, identificato con la brutalità di certi titoli: “Hanno preso il cinghialone”, all’indomani del primo avviso di garanzia a Bettino Craxi, più di recente “La patata bollente” o “Calano fatturato e Pil ma aumentano i gay”. Insomma, titoli a effetto, che cercano di prendere per la collottola un lettore sempre più distratto da un bombardamento mediatico che ai tempi dell’Indipendente e del Giornale era essenzialmente televisivo e oggi viene invece dai social media. Ai collaboratori Feltri ha sempre spiegato che stupire il lettore con gli effetti speciali era utile in prima pagina, in tutte le altre erano i contenuti a dover parlare. Qualcuno gli ha dato retta (per anni e tutt’oggi le pagine culturali del Giornale sono state e sono fra le migliori e più raffinate), altri meno, ma del resto Feltri, con la sua pipa, il suo vestire all’inglese, la popolarità, il successo, i cavalli, eccetera, era ed è, in un mondo un po’ sbrindellato come quello del giornalismo, un modello talmente eclatante che si capisce che ciascuno provi a imitarlo come può.
I titoloni, il turpiloquio, la spregiudicatezza con cui il fiancheggiatore di Manipulite (su L’Indipendente) entra nel mondo berlusconiano andando al Giornale, le andate e i ritorni dalla direzione di quest’ultimo a quella di Libero, tutto questo è noto. Si tende a dimenticare che se è vero che Feltri prese un “bel giornale, tranquillo ed elegante” che “tranquillamente non vendeva niente” e poi ne fece il suo battagliero Indi, il giornalismo anglosassone all’italiana, ammesso che sia mai esistito, non fu ammazzato da lui ma dai tempi. Andatosene dal Giornale, Montanelli fece per un anno un quotidiano, La Voce, caratterizzato dai fotomontaggi di Vittorio Corona e da titoli tutt’altro che pacati. Non è stato Feltri a “mettere la minigonna” al Corriere né se per questo agli altri grandi quotidiani, che negli anni Novanta impararono ad alternare l’alto e il basso, a comporre prime pagine a volume più alto, oggi a mettere sui propri siti notizie e immagini clickbait, insomma a far di tutto per guadagnare attenzione. E’ stato l’evolversi della tecnologia, l’ampliarsi del mercato della comunicazione, il venir meno della famosa “egemonia culturale”. Feltri è un paladino della carta stampata che meglio di altri ha cercato di conservarle uno spazio, mentre la concorrenza incalzava. Lo ha fatto, a differenza di altri, con piena consapevolezza e senza mai pensare che la fine di un mondo fosse la fine del mondo: “non credo affatto che i social abbiano contribuito a peggiorarci, credo invece che abbiano soltanto reso i nostri vizi più evidenti”. “Non ha alcun senso immaginare che i social, la televisione e in generale i mezzi d’informazione abbiano un dovere educativo, e nemmeno vorrei che questa fosse la loro funzione, per fortuna non viviamo in uno Stato etico”.
Se i titoloni, la spregiudicatezza, eccetera, sono cosa nota, altrettanto ormai lo sono le circostanze tutto fuorché facili della vita di Feltri: rimasto orfano a sei anni, poi vedovo a ventiquattro, ha dovuto alternare studio e lavoro (riuscendo comunque a laurearsi in scienze politiche), prima dell’arrivo al Corriere dell’informazione e poi al Corriere, dove ha preso la rincorsa per una carriera come poche. Irritante per il gusto di esserlo più che per vocazione, tutt’oggi gioca a far dare di matto a mezzo mondo (pensate all’ultima uscita sui ciclisti), ma è capace di dire e scrivere parole commoventi per i suoi gatti. Difficile dimenticare un suo pezzo sul “pensionamento” di Varenne. Tutto questo per dire che Feltri è cosa diversa dal suo cartonato, che gli avversari usano come bersaglio per le freccette. Se dal 1992 è stato il principale opinion maker dell’opinione pubblica non di sinistra, c’è qualche ragione che va oltre un fiuto di prim’ordine.
Si capisce che alcuni siano rimasti spiazzati dal leggere il titolo del suo nuovo libro: Il latino lingua immortale. Perché è più vivo che mai. Per una volta, il fondatore di Libero non è molto originale: in libreria non manca una folta pattuglia di elogi del latino, saggi di solito rivolti al pubblico degli ex studenti di liceo e pensati per indurli a far pace coi ricordi della propria adolescenza. Feltri riprende il tema centrale di un best seller di un’altra stagione, Siamo tutti latinisti di Cesare Marchi. Questo ne era l’incipit:
L’altra notte ho fatto un sogno. Invitato da un cineclub a una rassegna di film storici, Quo Vadis, Fabiola, Anno Domini, Marco Tullio Cicerone si congratulava con i presenti per i lusinghieri segni di sopravvivenza che continua a dare, dopo duemila anni, il suo latino, presunta lingua morta. Estromesso dalla scuola e dalla chiesa, esso si è preso una spavalda vendetta penetrando nel linguaggio della burocrazia, della politica, dell’economia, dei tribunali, dello spettacolo, dello sport, grazie alla sua straordinaria capacità di condensare il massimo di pensiero nel minimo di parole, “pregio non indifferente”, osservò Cicerone, “in un’epoca come la vostra, affetta da stitichezza concettuale e diarrea verbale” (disse proprio così).
Se quello di Marchi era una specie di dizionario dei prestiti latini entrati nell’uso comune anche degli italiani che il latino non l’hanno mai studiato (ad personam, et cetera, placet… et cetera, appunto), Feltri ne dissemina le proprie pagine (dal deficit di bilancio al cursus honorum di Mario Draghi), partendo dall’uso per indurre il lettore a riflettere sulla loro provenienza e sul “processo evolutivo” che dal latino porta all’italiano contemporaneo.
A fare apprezzare il latino a Feltri fu un insegnante, un “anziano monsignore che mi accolse sotto la sua protezione”, monsignor Meli, che lo aiutò a prepararsi alla maturità e gli fece
dal punto di vista strettamente educativo il sedere letteralmente quadrato, nel senso che mi teneva quattro o cinque ore al giorno a studiare le sue materie in seminario. Aveva una caratteristica, si rivolgeva a me parlandomi sempre e comunque o in bergamasco o in latino, non concepiva e non utilizzava nessun'altra lingua. Potete capire che in questo modo il latino ho dovuto impararlo per forza. All'inizio naturalmente non capivo un tubo, ma l'esigenza di comunicare con lui mi costringeva ad apprendere tutto il latino che era necessario e forse anche di più. Del resto, spesso le lingue si imparano meglio e più in fretta ascoltandole, e poi provando a usarle, che non limitandosi a studiarne le regole. Quando monsignor Meli è morto, per me è stato doloroso come se per la seconda volta mi fosse morto il padre. Pensate a come possa essermi rimasta nella testa una lingua che pian piano mi ero abituato a parlare, e con la quale quotidianamente comunicavo.
L’argomento centrale di Feltri è che “una buona conoscenza del latino permette una migliore comprensione dell’italiano”, perché il latino implica “la conquista di un processo rigoroso di analisi grammaticale e logica”. Il lettore si fa rapidamente l’idea che la familiarità col latino sia per Feltri un ingrediente essenziale del suo italiano - un italiano pulito, essenziale, efficacissimo (“qualche volta avrò esagerato, non faccio nessun tentativo per negarlo, ma almeno conosco la lingua italiana e sono sempre stato attentissimo a rispettarla”).
Potrei dire che il latino è una lingua taciturna (…) Sappiamo bene che in molti contesti risulta utilissimo essere celeri, rapidi, pronti ad arrivare istantaneamente al punto e a cogliere nel segno, senza tanti giri di parole e tanti fronzoli: certo, ci sono quelli che preferiscono voli pindarici e mille arzigogoli lessicali. Contenti loro. Io sospetto comunque che si tratti di individui che non amino la lingua, o comunque non il latino, o non abbastanza.
Il latino lingua immortale è anche una collezione di ricordi e giudizi. Non mancano pagine autocritiche: Feltri “non è per niente orgoglioso” di molte delle cose scritte (“Cinghialone” Craxi, “Lumino” Mino Martinazzoli) all’epoca di Tangentopoli, continua a credere che l’Italia avesse bisogno di una “boccata d’aria fresca” come la Seconda Repubblica, nega che la prima avesse un ceto politico poi così brillante, ammette “purtroppo quello che ci resta oggi è forse ancora peggio di ciò di cui ci liberammo”.
Le pagine dedicate allo scontro fra difensori del liceo classico e fautori della cultura scientifica, interpretati gli uni e gli altri come una qualche versione di destra e sinistra, non sono le migliori del libro. Che invece sono quelle nelle quali il racconto autobiografico e l’analisi politica delineano i tratti essenziali di un modo di vedere le cose. Il “conservatorismo” di Feltri non sta solo nella difesa del latino né nell’aver difeso e sostenuto una certa parte politica. Sta soprattutto nell’essere pienamente consapevole dell’inemendabile imperfezione dell’essere umano e nello scoprirsi convinto che in quell’imperfezione non c’è nulla di male, bisogna solo farci i conti. E’ importante diffidare delle utopie (“finiamo con l’aspettarne in eterno e finiamo pure per non vederle mai”) ma anche dell’eccesso di entusiasmo per la politica in generale:
La politica è uno strano circo, nel quale le bestie ammaestrate non stanno al centro della pista per esibirsi, ma tra gli spettatori. Le bestie ammaestrate siamo noi che applaudiamo. E questo i politici e gli amministratori lo sanno, conoscono il meccanismo e lo usano, grazie a queste strane regole vivono e sopravvivono, costruiscono le loro lunghe carriere. La politica è un universo che somiglia in fondo a uno stadio di calcio. Crediamo di essere lì e di essere perfettamente in grado di conservare la lucidità per pensare, in realtà il tifo ci acceca e ce lo impedisce, ogni giudizio che esprimeremo sarà il frutto dei nostri preconcetti e delle nostre passioni.
Non c’è nulla di straordinario né di male, in questo, dice Feltri, basta saperlo e per questo contenere la nostra naturale presunzione. Cercare di capire il meccanismo, e non esserne preda, vuol dire per esempio accorgersi della “disonestà intellettuale” dei politici che, finiti all’opposizione, imputano al governo che ha preso il posto del loro di non fare ciò che non hanno fatto loro per primi. Feltri parla della sinistra e del salario minimo (sul tema, la sua posizione è netta: “la faccenda complicatissima degli stipendi che andranno a chi lavora” va lasciata “ai meccanismi del libero mercato”) ma gli esempi potrebbero essere molti. Cercare di capire il meccanismo, e non esserne preda, vuol dire soprattutto capire che la bussola della politica dev’essere la prudenza: “non dimentichiamo che siamo su un pianeta che uscirebbe distrutto dall’esplosione di poche testate nucleari, e noi intanto continuiamo a puntarci gli uni contro gli altri le poco meno di quindicimila che abbiamo costruito”.
Il latino che riaffiora negli sponsor, nei quorum e nei referendum serve a Feltri per ricordarci che la prima fonte della prudenza è l’introspezione e vale la pena citare per intero la conclusione del libro:
Curae leves loquuntur, ingentes stupent, diceva Seneca. I piccoli dolori ti inducono a parlare, quelli grandi ti rendono muto. E infatti, al cospetto di una guerra o anche di una vicenda terribile come quella di Leffe, a volte non riusciamo a reagire se non con il silenzio. Stiamo zitti come chi si vergogna. Perché i lupi ci sembrano sempre altri, ma in fondo abbiamo paura che il gene della ferocia dorma dentro ognuno di noi. Forse il senso della vita è provare a non svegliarlo.
E’ il caso di dire: Amen, anche se non è latino.
Vittorio Feltri, Il latino lingua immortale. Perché è più vivo che mai, Milano, Mondadori, 2024, pp. 166.