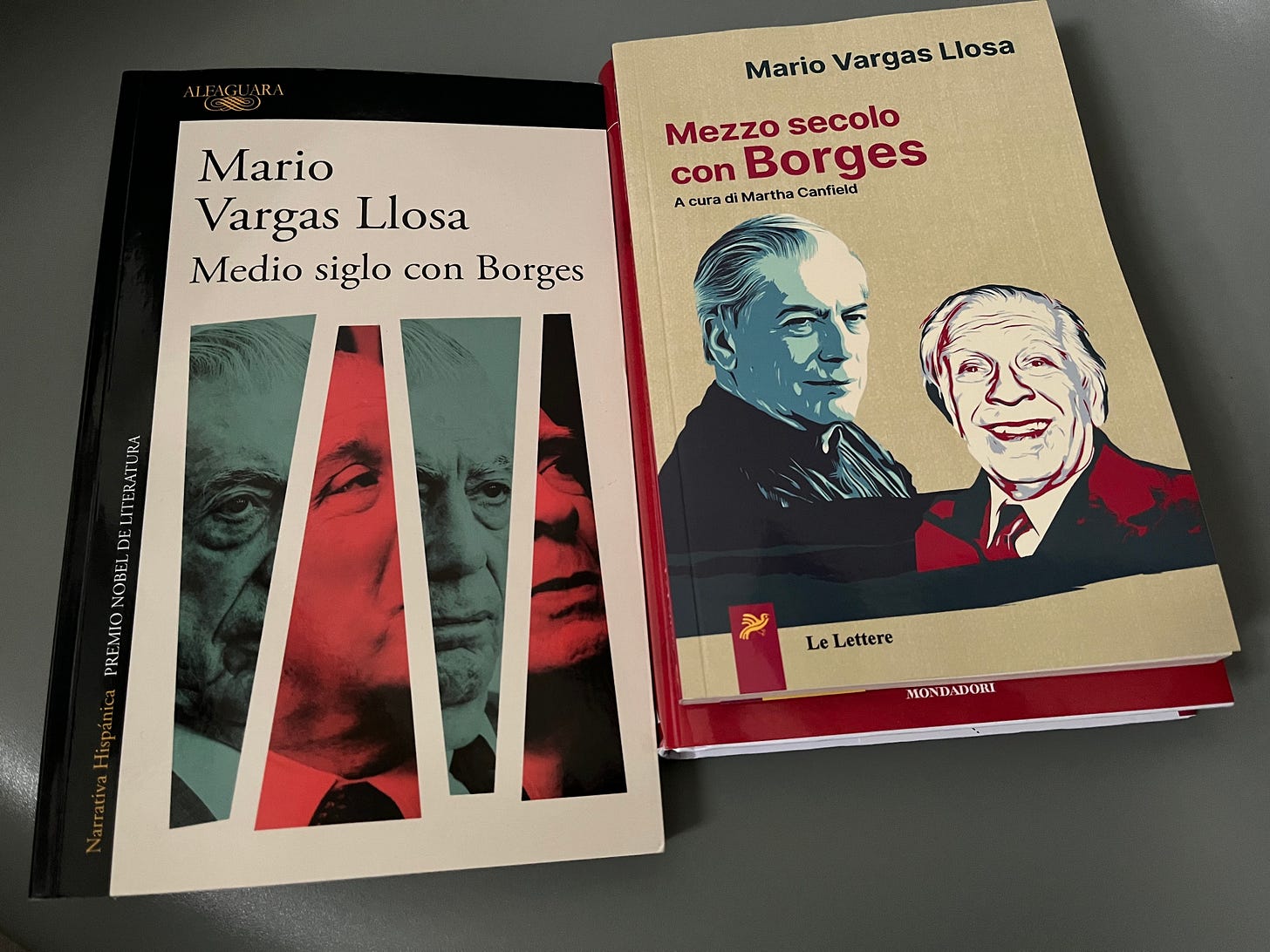Ci sono autori che leggiamo da ragazzi e ci appassionano, anzi ci travolgono, e tuttavia ad anni di distanza quasi non riconosciamo più. E ci sono altri autori ai quali non riusciamo a non tornare, trovandoci sempre qualcosa di nuovo e soprattutto qualcosa che ci ricorda come fosse scoccata la scintilla, perché fosse cominciata la passione.
Per Mario Vargas Llosa è il caso rispettivamente di Jean-Paul Sartre, scrittore importante come pochi nei suoi anni di formazione, e Jorge Luis Borges. Del suo tornare a Borges il Nobel peruviano dà conto in questo Mezzo secolo con Borges, ora disponibile in italiano grazie a Le Lettere e Martha Canfield, che ha organizzato uno splendido convegno vargasllosiano a Firenze un paio di settimane fa.
Vargas Llosa è tornato spesso sul suo canone letterario: da Flaubert che gli ha “insegnato che il talento significa disciplina tenace e grande pazienza” a Faulkner da cui ha appreso “che è la forma ciò che esalta o impoverisce le trame”, e poi Hugo, Balzac, Cervantes. Borges è uno scrittore quanto più lontano, per prosa e interessi, dal Nobel peruviano. Anzi rappresenta “in maniera chimicamente pura, tutto ciò che Sartre mi aveva insegnato a odiare: l’artista evaso dal suo mondo e dall’attualità in un universo intellettuale di erudizione e fantasia; lo scrittore sdegnoso della politica, della storia e persino della realtà, che esibiva spudoratamente il suo scetticismo e il suo sorridente disprezzo verso tutto ciò che non fosse letteratura; l’intellettuale che non solo si permetteva di ironizzare sui dogmi e sulle utopie della sinistra, ma che portava la sua iconoclastia sino al punto di affiliarsi al Partito Conservatore, con l’insolente argomento che i gentiluomini si uniscono di preferenza alle cause perse”.
Vargas Llosa ricorda come Borges abbia scritto solo cose brevi, racconti brevi, saggi brevi, come se la scrittura fosse una parentesi fra una lettura e l’altra. Alla sua “furiosa creatività” Vargas Llosa riconosce il merito di aver rivoluzionato lo spagnolo, senza curarsi della “predisposizione naturale dello spagnolo per l’eccesso”, facendone una lingua più secca e decisa, meno barocca. Nella bellissima poesia che apre il libro (Borges o la casa de los jueguetes) Vargas Llosa dice che inventò una prosa che aveva “tante parole quante idee”. Il modello, per Borges, era quello dei suoi amati anglosassoni. Vargas Llosa ne chiede conto all’argentino in una intervista del 1981, inclusa nel libro. E Borges, che aveva studiato a Ginevra e a Ginevra morì, che aveva un’istitutrice inglese e l’ossessione di penetrare nel mistero di tutte le lingue, gli risponde che una delle ricchezze argentine è “la nostalgia. La nostalgia dell’Europa soprattutto, che un europeo non può sentire perché un europeo non si sente europeo ma, diciamo, inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, russo…”
La distanza che Borges pone fra sé e la politica, quella così inconcepibile a un intellettuale impegnato sul calco di Sartre, per Vargas Llosa diventa col tempo un motivo di sintonia:
Sicuramente Borges provava uno sprezzante disinteresse per la politica, ma questo non fa di lui un apolitico: disprezzare la politica è una presa di posizione tanto politica come adorarla. Certo, questo suo sdegno era conseguenza del suo scetticismo, della sua incapacità di abbracciare qualsiasi fede, religiosa o ideologica.
In realtà, sostiene Vargas Llosa, Borges è stato un “ostinato individualista, costruttivamente allergico a cedere un minimo della sua indipendenza (…) il che lo faceva nemico dichiarato di tutte le dottrine e formazioni politiche collettiviste, come il fascismo, il nazismo o il comunismo”.
Di ciò Vargas Llosa gli rende merito. Per essere individualista nell’Argentina degli anni Trenta e Quaranta, ci voleva “convinzione e coraggio”.
La viscidità propria del peronismo si è incaricata di far dimenticare che in quegli anni Peron e il suo regime erano filo-nazisti (…) In quegli anni Borges non smise di denunciare la ‘pedagogia dell’odio’ e il razzismo dei nazisti, di difendere gli ebrei e di manifestare la sua solidarietà con la causa degli Alleati.
Nel nazismo, Borges ritrovava “l’escrescenza di un male più esteso: il nazionalismo”. Si pensi soltanto a una novella come “Il Parlamento” (ne Il libro di sabbia) dove l’argentino immagina la nascita di un Parlamento del mondo alla fin fine inutile, perché il vero Parlamento del mondo è dato dai continui scambi, dalle interazioni quotidiane di ciascuno di noi, da una storia comune cui ciascuno contribuisce a suo modo. Pochi esempi di “umanesimo liberale” sono tanto luminosi quanto quelle pagine di Borges, scritte senza la minima tentazione didascalica.
Vargas Llosa ricorda che Borges si burlava di quei “torbidi sentimenti patriottici” che servivano per giustificare la mediocrità artistica. “Idolatrare uno scorfano perché autoctono, dormire per la patria, ringraziare la noia quando è una elaborazione nazionale mi sembra un assurdo”. L’autore de La città e i cani fatica a comprendere la simpatia manifestata dall’altro per il golpe di Aramburu e il regime di Videla, che alla fine spiega con l’intensità dell’anti-peronismo borgesiano ma anche col suo disincanto circa le effettive possibilità della democrazia in America Latina.
Non è un libro dove si parli soltanto di questioni politiche, per carità. Nell’ultimo articolo della raccolta, difende la storia d’amore fra Borges e Maria Kodama (“la prima volta che l’anziano scrittore abbia goduto di un amore corrisposto”), invece spesso criticata dagli appassionati dell’argentino, convinti che in qualche modo la Kodama ne abbia impoverito la vena creativa.
Quando sente di stare morendo, Borges lo confida a Maria Kodama che gli domanda se vuole un sacerdote. In realtà ne vuole due: un cattolico, in ricordo di sua madre, e un pastore protestante, in omaggio a sua nonna inglese e anglicana. Sorride Vargas Llosa: “letteratura e senso dell’umorismo, fino all’ultimo istante”.
Mario Vargas Llosa, Mezzo secolo con Borges (2020), a cura di Martha Canfield, Firenze, Le Lettere, 2022, pp. 136.