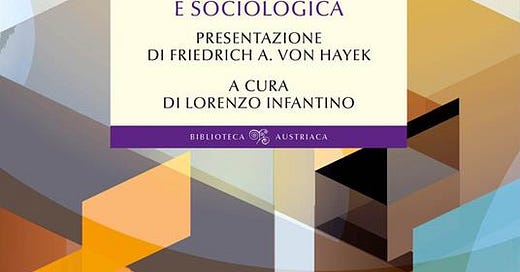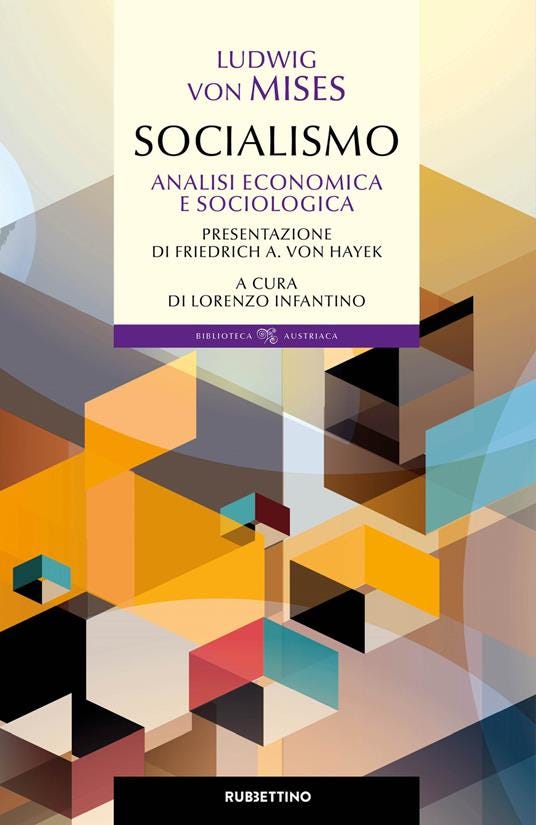Quest’anno ricorrono i cent’anni dalla pubblicazione di Socialismo di Ludwig von Mises (1881-1973). Nel 1920, Mises aveva scritto un breve e lucidissimo saggio nel quale dimostrava che: ciascuno di noi scegliendo certi beni o servizi esprime un giudizio di valore, il quale riguarda la preferenza per quel bene di consumo ma si riflette anche sui beni di ordine superiore necessari a realizzarlo; che il gioco reciproco delle innumerevoli valutazioni soggettive di tutti noi “pone in essere” i valori di scambio che sono attribuiti ai beni; che grazie al fatto che tali valori di scambio sono espressi in moneta noi possiamo orientarci fra le miriadi di scelte economiche possibili, facendo “risalire” le preferenze espresse per i beni di consumo ai beni di ordine superiore che servono a produrli. I prezzi sono pertanto indicatori sintetici che consentono di decidere come far uso di una certa risorsa, fra tutte le alternative immaginabili.
Perché la società possa disporre di questo sistema per orientare l’utilizzo di risorse scarse debbono verificarsi due condizioni: la prima è che facciano parte del novero dei beni scambiabili non solo i beni di consumo ma anche le cose che servono a fare altre cose, i beni di ordine superiore. La seconda è la presenza di un mezzo di scambio accettato universalmente, la moneta, utilizzabile anche per scambiare i beni di ordine superiore. In assenza di queste condizioni, non ci può essere “calcolo economico”, mancano gli elementi per avere produzione economica ovvero per provare a organizzare la produzione in modo che le risorse finiscano là dove più risultano produttive per la società. Questo proprio perché tale allocazione di risorse non è scolpita nella pietra, non avviene una volta e per sempre, ma è al contrario continuamente esposta alle sollecitazioni del cambiamento (si tratti di novità tecnologiche o semplicemente di un’evoluzione delle preferenze delle persone).
Per tale ragione il calcolo economico era “impossibile” in una economia pianificata, cioè in assenza di diritti di proprietà sui fattori produttivi. Il saggio di Mises fece scandalo, infiammò il cosiddetto “dibattito sul calcolo economico”, indusse i più acuti fra gli economisti socialisti dell’epoca a ricalibrare le proprie posizioni, immaginando meccanismi di “socialismo di mercato” che consentissero di surrogare i prezzi anche dopo la nazionalizzazione dei mezzi di produzione. In pratica (Mises aveva previsto anche questo) il fatto che vi fossero, a fianco dell’economia sovietica, economie di mercato consentì ai pianificatori di utilizzare queste ultime come serbatoio di “prezzi di riferimento”.
Socialismo, il libro, amplia queste considerazioni aggiungendovi un’analisi penetrante del socialismo come dottrina politica. E’, tutt’oggi, una lettura che non può lasciare indifferenti, un vero classico nel senso (per stare a una delle famose definizioni di Calvino) che ogni rilettura è una scoperta come la prima.
Mises viene ogni tanto accusato di incarnare un liberalismo “materialista”. Il suo argomento a favore dell’economia di libero mercato è una sorta di filosofia politica pensata per la persona comune: il capitalismo ha prodotto più ricchezza di qualsiasi altro sistema nella storia, ha diffuso il benessere fino ai gradini più bassi della scala sociale, significa elettricità, riscaldamento, acqua corrente, prodotti per l’igiene personale, mezzi di trasporto finalmente disponibili per la quasi totalità della popolazione. Il socialismo implicherebbe una regressione a una divisione del lavoro più rudimentale, le risorse verrebbero allocate attraverso le scelte discrezionali di alcuni grandi “decisori”, che senz’altro si presentano come lungimiranti e di spirito umanitario ma che non possono cogliere la complessità delle scelte di produzione in economie nelle quali la divisione del lavoro è quanto più articolata.
Forse proprio per questo Mises era ossessionato dal ruolo delle idee, economiche e politiche. La storia è decisa dal gioco degli interessi? Ma l’interesse di quasi tutti, eccezion fatta per il manipolo di “intellettuali” che vorrebbe dirigere l’orchestra in un Paese socialista, coincide con l’economia di mercato, e questo è vero soprattutto per i meno abbienti. Se tanti non se ne avvedono è proprio perché sono indotti a interpretare il proprio interesse in un modo o nell’altro sulla base di un certo insieme di idee. Scrive Mises nelle conclusioni all’edizione americana di Socialismo (sono pagine che pubblica nel 1947 sotto il titolo Planned Chaos):
Non le mitiche “forze produttive materiali”, ma la ragione e le idee determinano il corso delle vicende umane. E, per fermare la tendenza verso il socialismo e il dispotismo, sono necessari senso comune e forza morale.
Grazie a Lorenzo Infantino, Socialismo è disponibile in una nuova, eccellente edizione italiana nella “Biblioteca austriaca” dell’editore Rubbettino.
Sula Scuola austriaca d’economia, di cui Mises è stato il massimo esponente nel Novecento, vi segnalo questo nuovo corso on line dell’Istituto Bruno Leoni. Per gli iscritti, lezioni e materiale didattico saranno disponibili anche on demand.