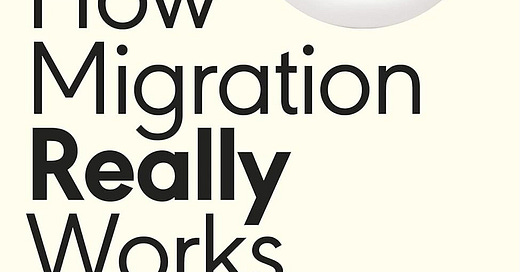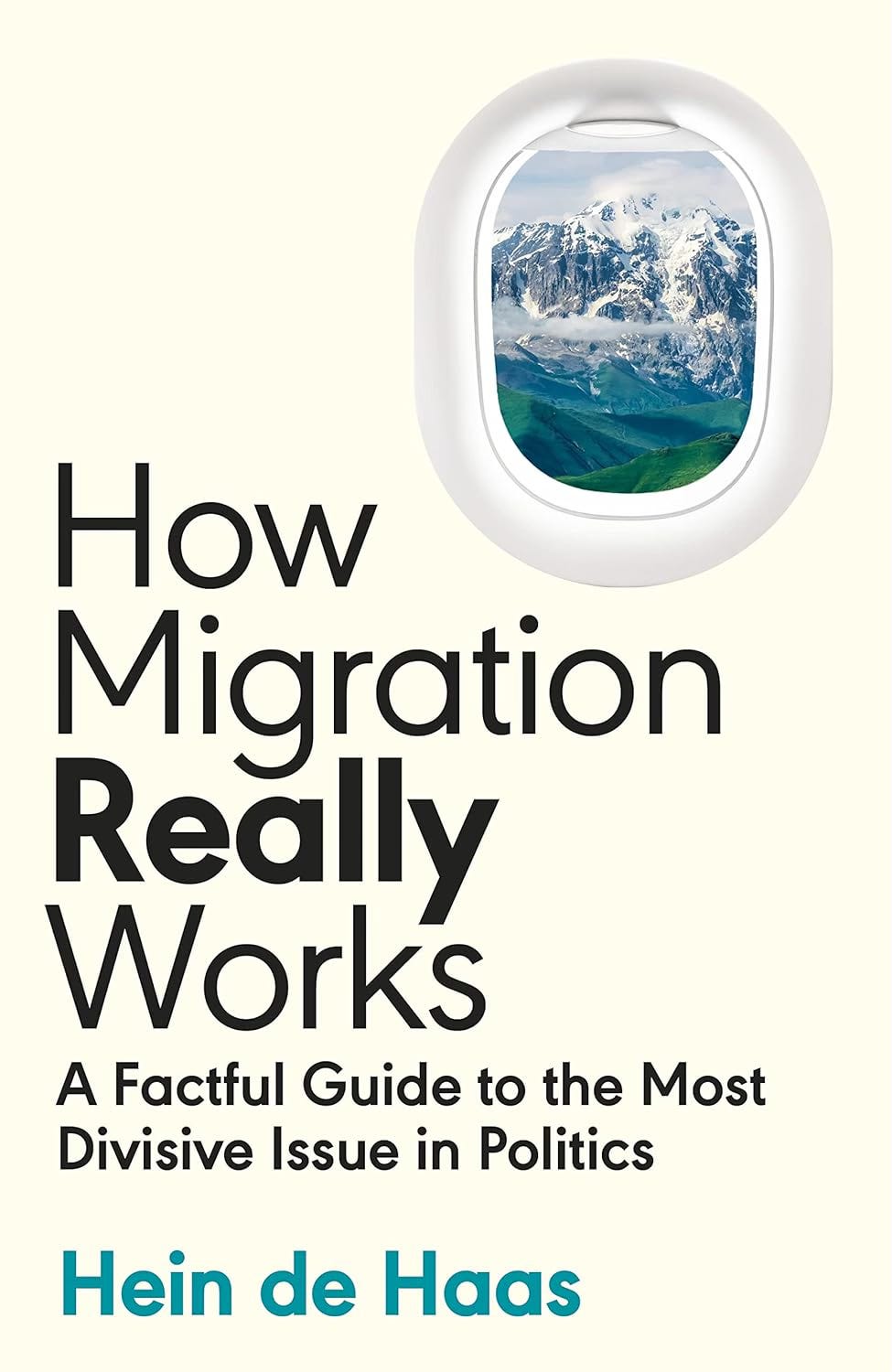Qualche mese fa, arrivava nelle sale cinematografiche un film bellissimo e spiazzante. Io capitano di Matteo Garrone racconta il viaggio verso l’Europa di due ragazzi senegalesi. “Viaggio” per noi è chiudere le valigie, prendere il taxi, raggiungere l’aeroporto, salire in aereo, vedersi un film, dormicchiare, sfogliare distrattamente l’Economist, dormicchiare di nuovo, scendere dall’aereo, prendere un altro taxi. Il loro è un’altra cosa: è un incontro con tutte le sfumature della cattiveria umana e con qualche insperato soffio di bontà. Allo spettatore non è risparmiato nulla. Eppure molti recensori hanno descritto la pellicola di Garrone come una “fiaba”. Gianni Canova l’ha spiegato coniando un neologismo: Io capitano “non è un film ‘miserabilista’, che racconta il viaggio della speranza di disperati e morti di fame”. I due protagonisti fanno una vita non peggiore di quella di tanti coetanei nella stessa città, si vestono non troppo diversamente dai loro omologhi occidentali, non sono spinti a partire dalle loro famiglie che anzi tentano di trattenerli, a muoverli non è la prospettiva di un salario più alto. “I ragazzi protagonisti decidono di investire tutto quello che hanno per inseguire un sogno”.
Io capitano mette in discussione, col candore del grande cinema, il senso comune sull’immigrazione. Che sia “di destra”: l’“invasione” da parte di un esercito che desidera i nostri soldi e dichiara guerra alla nostra cultura. O che sia “di sinistra”: i migranti come massa di disperati tutti egualmente tali, spinti in mare dalle circostanze, in larga misura frutto di centinaia d’anni di sfruttamento occidentale, da accogliere a braccia aperte perché le loro miserie sono solo colpa nostra. Generalizzazioni che sembrano negare l’individualità del migrante, che avrà motivazioni e obiettivi non necessariamente uguali a quelli degli altri migranti, e che implicitamente insistono sulle dimensioni del fenomeno, descritto da tutti come senza precedenti o quasi e quindi bisognoso di soluzioni drastiche e nuove. Le migrazioni, fateci caso, ormai sono sempre “grandi”.
How Migration Really Works di Hein de Haas è un libro strepitosamente documentato ed esemplarmente chiaro, scritto appunto per mettere le cose in chiaro. Professore di sociologia in Olanda, de Haas ha insegnato per anni a Oxford, dove ha fondato l’International Migration Institute. Il saggio è il frutto di anni di lavoro di ricerca.
Sono ventidue i “miti” sull’immigrazione che lo studioso olandese si propone di smentire. Alcuni sono miti “di destra” (le nostre società stanno perdendo la loro identità, l’integrazione non funziona, etc), altri sono miti “di sinistra” (l’immigrazione è figlia della povertà, i confini si stanno richiudendo, etc). Il più importante è forse il primo, il mito-cornice nel quale s’inseriscono tutte le ansie e i catastrofismi.
A causa della globalizzazione, viaggiare è più facile di quanto non sia mai stato e lo stesso vale per l’essere connessi su lunga distanza. Dagli anni Novanta, la televisione via satellite, Internet e i telefoni cellulari hanno causato una rivoluzione nella connettività globale. Persino nei più piccoli villaggi in Paesi come il Guatemala, l’Etiopia e l’Afghanistan, la gente ora può connettersi col resto del mondo. Ciò ha allargato gli orizzonti dei giovani in tutto il mondo. L’esposizione alle immagini di ricchezza e lusso in Occidente sembra aver alimentato una febbre della migrazione fra i giovani che hanno il desiderio di assaggiare la vita nelle terre dove scorrono il latte e il miele.
Tutto ciò ci rende intuitivamente verosimile che l’immigrazione sia cresciuta a dismisura, anche perché, spiega Hein de Haas, lo stesso ci hanno detto grandi organizzazioni internazionali come l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Eppure “nonostante l’idea che la migrazione sia al suo massimo storico sia diventata una specie di verità indiscutibile, i fatti raccontano una storia diversa”.
I livelli correnti di migrazione internazionale non sono né eccezionalmente alti né in crescita. In realtà, nei decenni passati, il numero dei migranti internazionali è rimasto straordinariamente stabile. Secondo la gran parte delle definizioni, un migrante internazionale è una persona che risiede in un Paese diverso da quello nel quale è nato per un periodo che è almeno di 6/12 mesi. Utilizzando questa definizione, e secondo i dati della United Nations Population Division, nel 1960 c’erano circa 93 milioni di migranti internazionali nel mondo. Questo numero crebbe a 170 milioni nel 2000 ed è aumentato poi fino agli stimati 247 milioni del 2017. Di primo acchito, questo sembra un aumento sbalorditivo. Tuttavia, la popolazione mondiale è cresciuta grossomodo allo stesso ritmo, da 3 miliardi nel 1960 a 6,1 miliardi nel 2000 e a 7,6 miliardi nel 2017. Dunque, se esprimiamo il numero di migranti internazionali come quota della popolazione mondiale, vediamo che i livelli relativi di migrazione sono rimasti stabili intorno al 3 per cento.
Inoltre, per quanti problemi possano esserci oggi con il registrare gli immigrati irregolari, quanto più andiamo indietro nel tempo e tanto più è probabile che le stime siano per difetto.
La replica di senso comune potrebbe essere: sarà pur vero che la percentuale della popolazione che vive al di fuori del proprio Paese è rimasta la stessa, ma ne è cambiata la composizione. Oggi sono sempre di più i richiedenti asilo, alcuni dei quali sono tali solo di nome, si tratta di “migranti economici travestiti”. In realtà, spiega Hein de Haas:
I rifugiati sono assai meno di quanto suggeriscano la copertura mediatica e la retorica politica. Dagli anni Cinquanta, i numeri dei rifugiati sono stati fra lo 0,1 e lo 0,35 per cento della popolazione mondiale, e i rifugiati formano soltanto una piccola parte della popolazione dei migranti internazionali. Fra il 1985 e il 2021, la dimensione stimata della popolazione totale dei rifugiati internazionali era fra i 9 e i 21 milioni, che significa fra il 7 e il 12 per cento del numero complessivo dei migranti internazionali nel mondo.
Non ci sono prove “di un aumento nel lungo termine dei rifugiati”. Esso semmai subisce delle oscillazioni: cresce cioè in alcuni momenti specifici, di solito in corrispondenza di guerre. Sono i conflitti degli ultimi anni, a cominciare dalle guerre civili in Libia, Yemen e Siria, che spiegano perché il numero di rifugiati “ha raggiunto i 21,3 milioni alla fine del 2021, e i 26,7 milioni nel 2022 (in gran parte a causa della guerra in Ucraina). Ma per quanto i numeri dei rifugiati siano cresciuti, i livelli attuali sono in realtà simili a quelli dei primi anni Novanta: nel 1992 i rifugiati contavano per lo 0,33 per cento della popolazione mondiale e questa percentuale era lo 0,25 nel 2021”. Se Hein de Haas smentisce anche che sia “fuori controllo” l’immigrazione economica che cerca di avvantaggiarsi dello stato di richiedente asilo, egli spiega pure come “la vera crisi dei rifugiati non avviene in Occidente, ma nelle regioni d’origine. Alcuni dei Paesi più poveri del mondo ospitano un gran numero di rifugiati. Mentre nel 2018 i rifugiati nati nei Paesi africani erano 6 milioni, i Paesi africani ospitavano nello stesso anno 5,5 milioni di rifugiati, provenienti da nazioni confinanti”.
Riassumere anche solo gli argomenti cruciali di un libro così ricco è difficile. Vediamo però velocemente un paio di altri “miti”.
Si dice spesso che il cambiamento climatico comporterà un aumento delle migrazioni. Hein de Haas contesta l’idea anzitutto sul piano teorico: essa si basa sull'ipotesi “che l'innalzamento del livello del mare allontani le persone dalle aree costiere. Tuttavia, non possiamo presumere che le aree più basse saranno semplicemente sommerse. Questo perché i processi di sedimentazione - che portano alla crescita del territorio - possono controbilanciare l'effetto dell'erosione e dell'innalzamento del livello del mare, che portano alla perdita di territorio”. Ma spiega anche come l’esperienza che abbiamo dei disastri ambientali finora suggerisca il contrario: cioè che quando una catastrofe naturale sconvolge la vita delle persone esse si trovano ad avere meno risorse e quindi meno possibilità di spostarsi.
Ciò ci aiuta a capire come anche un altro mito sia basato su un fraintendimento: l’unico modo per ridurre l’immigrazione è stimolare lo sviluppo economico nel Paese d’origine? L’argomento è usato sia dalla destra che dalla sinistra: la prima tende a proporre disegni dal vago sapore corporativo-colonialista (del resto, si chiama “Piano Mattei”), che dovrebbero indirizzare gli investimenti di alcune grandi imprese verso economie da cui parte della gente che preferiremmo “aiutare a casa propria”. La seconda insiste (sin dai tempi dei maxi-concerti a tema umanitario) sulla necessità di aumentare gli aiuti allo sviluppo: aiuti non da-economia-a-economia ma da-governo-a-governo (bisognerebbe rileggere il grande Peter Bauer). La versione liberale è che gravare con dazi pesanti sull’importazione, per esempio, del famigerato olio tunisino non servirà certo a diminuire l’afflusso di immigrati tunisini. Se non si vogliono gli uni, che non si tenga fuori dai nostri supermercati l’altro.
Ci sono ottime ragioni per avere scambi più aperti possibili con altri Paesi (ci saranno consumatori che domandano l’olio tunisino, per esempio). Ma, spiega de Haas, l’emigrazione in realtà “aumenta quando i Paesi poveri diventano più ricchi e diminuisce soltanto quando lo status di questi Paesi passa da Paesi a medio reddito a Paesi ad alto reddito”. Una dinamica che spiega, se volete, anche l’andamento dell’emigrazione europea verso gli Stati Uniti.
Purtroppo i dati contano nulla, se l’opinione pubblica li percepisce diversamente. Hein de Haas ridimensiona però anche l’ostilità delle persone verso l’immigrazione. I sondaggi Gallup per esempio mostrano che “la quota di americani favorevoli a livelli di immigrazione più elevati è rimasta stabile fra il 1966 e il 2002, attorno al 7 per cento, dopo di che è cominciata a salire fino a raggiungere il 34 per cento nel 2020”. Votano tutti per Biden? Secondo il Pew Research Center, “la quota di adulti che si definiscono repubblicani a favore di maggiore immigrazione è cresciuta dal 15 al 22 per cento fra il 2006 e il 2018”.
De Haas cita sondaggi relativi ad altri Paesi che restituiscono una visione altrettanto sfumata degli atteggiamenti diffusi verso gli immigrati.
Solo una minoranza di persone è fortemente avversa all’immigrazione o ha un atteggiamento apertamente razzista. (…) Uno studio recente su Giappone e Germania suggerisce che il sentimento anti-immigrazione è particolarmente alto fra gruppi a basso reddito con opinioni “di sinistra” circa la responsabilità dei governi nel proteggere i lavoratori locali. Questi gruppi tipicamente avvertono di avere perso terreno nel processo di liberalizzazione economica e si sentono dimenticati dalle élites politiche.
Il cattivo della storia di Hein de Haas è il ceto politico. A partire dal crollo del muro di Berlino, scrive il sociologo olandese, i leader occidentali hanno prima acceso il fuoco di un dibattito fuorviante sull’immigrazione e poi ci hanno soffiato. Ma difficilmente si può dir meglio di chi quel dibattito pubblico lo costruisce giorno dopo giorno, la stampa e tutti coloro che a vario titolo contribuiscono a formare la pubblica opinione. Il lavoro di de Haas non è convincente semplicemente per la ricchezza di dati e informazioni: sulla base di anni passati a intervenire in talk show e convegni, si è convinto che “non basta divulgare i fatti”, pensando che parlino da soli. Bisogna cambiare il modo di vedere e raccontare le migrazioni: in primis superando quella visione idraulico-meccanicistica per cui le persone verrebbero “spinte” o “tirate” da una parte o dall’altra e non sono invece agenti che decidono, ciascuno sulla base dei proprio desideri, delle proprie possibilità, delle proprie attitudini. De Haas vede le migrazioni come parte del processo di sviluppo, sottolinea come una maggiore mobilità (in primis, una maggiore mobilità all’interno dei confini nazionali) si accompagna alla crescita economica, che coincide con lo spostamento dalle campagne alle città. La cornice teorica in cui si inserisce è debitrice al geografo culturale Wilbur Zelinsky e in special modo al suo saggio “The Hypothesis of the Mobility Transition”.
L’ultimo capitolo del libro, quello “programmatico”, non abbozza un che fare ma ci ricorda che molte volte, quando parliamo di immigrazione, non dovremmo parlare (solo) di immigrazione. Su temi come la sicurezza, la presunta crisi dell’immigrazione è, di fatto, più che altro un sintomo dell’incapacità degli Stati di svolgere in modo minimamente decoroso il primo dei loro compiti: proteggere la vita e i beni delle persone. Nello stesso tempo, se parliamo veramente di “lotta all’immigrazione” dobbiamo sapere che questa implica non solo una forte ri-regolamentazione dei mercati del lavoro, ma forse anche una loro “militarizzazione”. Gli stessi che vorrebbero limitare pesantemente l’afflusso di immigrati sono disponibili a ridurre ancora di più la libertà economica dei datori di lavoro?
Parlare di immigrazione in modo più pacato e considerando davvero i dati a nostra disposizione non basta ma è il primo passo. “Giova deliberare senza conoscere?”, si chiedeva Luigi Einaudi. Anche tenere comizi o sermoni, senza conoscere, non solo non giova ma indebolisce la società e l’opinione pubblica.
Hein de Haas, How Migration Really Works: A Factful Guide to the Most Divisive Issue in Politics, London, Viking, 2023, pp. 464.