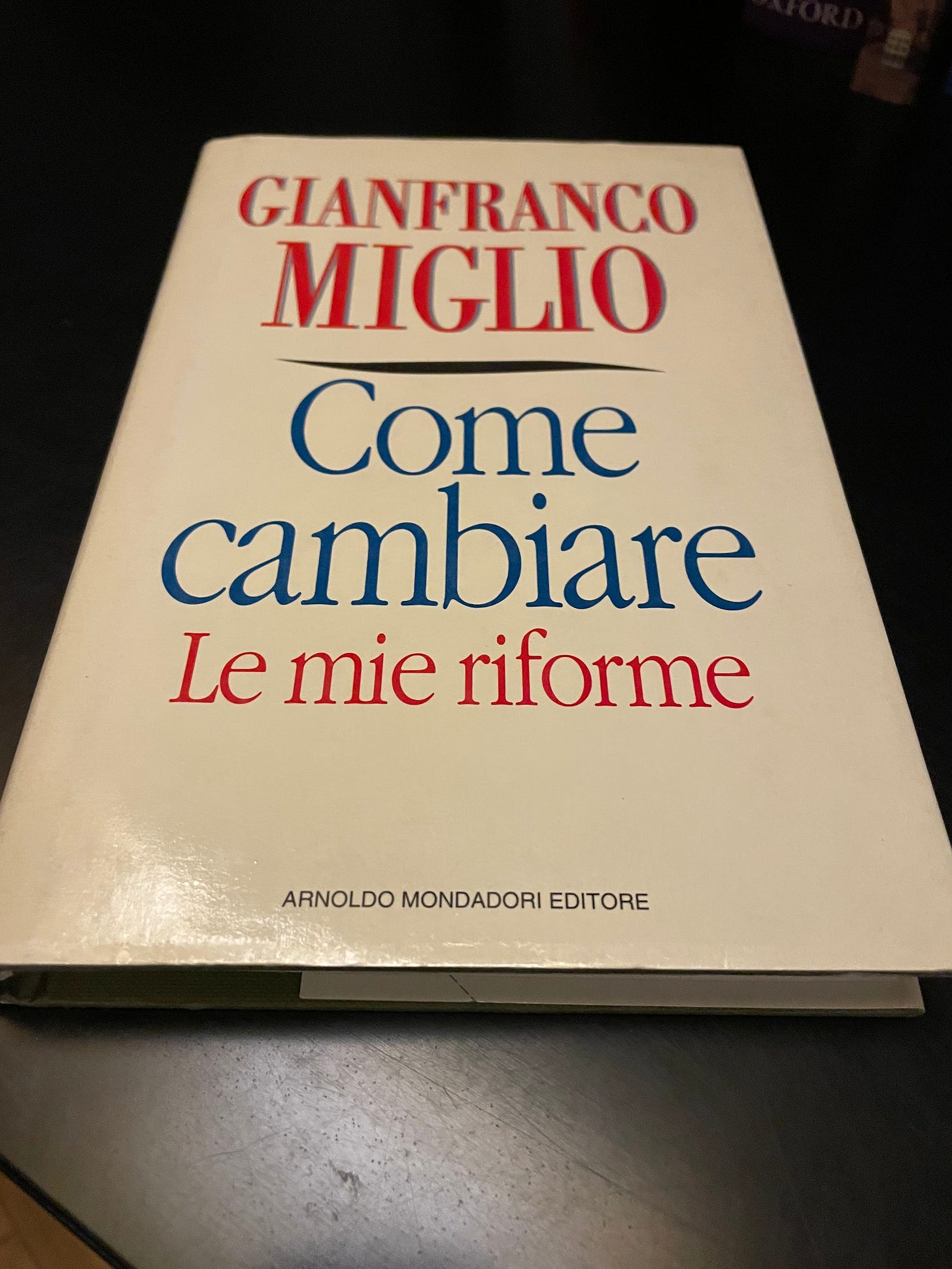Di riforme istituzionali in Italia parliamo da quarant’anni. E’ difficile sostenere che il bilancio sia entusiasmante. Meno entusiasmante ancora è come la qualità del dibattito sul tema sia peggiorata nell’ultimo decennio.
Ripensiamo agli anni Novanta. Dopo i referendum del ‘92 e del ‘93, c’era la speranza concreta che si potesse mettere mano all’architettura costituzionale. Non era uno scandalo e anzi gli stessi partiti, quelli che erano sopravvissuti al crollo della prima Repubblica “a sinistra” come quelli che a destra stavano prendendo forma, portavano in Parlamento costituzionalisti e politologi. Con l’ambizione di metterli al lavoro. C’erano idee e sfumature diverse ma nessuno sosteneva che tutto andasse bene semplicemente così com’era: il bubbone esploso con Tangentopoli, uno Stato “imprenditore” e “prenditore” che lasciava ben poco spazio alla società italiana, impediva di negare l’evidenza.
Questo libro di Gianfranco Miglio era un autentico manifesto. L’autore era uno dei massimi scienziati sociali del Paese, a lungo Preside della Facoltà di Scienze Politiche della Cattolica, per quanto eccentrico era pienamente riconosciuto, nel suo valore, dall’establishment. Con molti esponenti politici, da Bettino Craxi a Francesco Cossiga, aveva avuto rapporti diretti. A un certo punto, però, Miglio divenne l’ “ideologo” della Lega, trasformando in breve tempo certe disordinate istanze autonomiste in un “programma” di trasformazione federale dello Stato italiano.
I suoi colleghi si chiedevano come facesse quello che Carl Schmitt considerava “il maggior tecnico delle istituzioni e l'uomo più colto d'Europa” ad andare a braccetto con l’Umberto Bossi più ruspante, quello del gesto dell’ombrello a Margherita Boniver e delle foto in canotta. Il sodalizio durò quel che durò, ma Miglio riconobbe come la Lega fosse animata dal realistico riconoscimento di quello che era e tutt’ora è il grande fatto della politica italiana:
la dissennata politica della spesa pubblica clientelare ha preso la forma di un gigantesco trasferimento di risorse finanziarie dalle regioni settentrionali a quelle del Meridione, dando luogo all’emergere di due Italie: una del Nord, tendenzialmente europea, e una del Sud, tendenzialmente mediterranea. (…) come l’esperienza quotidiana insegna, dovunque arriva la pubblica amministrazione alla corruzione si sposa la plateale inefficienza.
Bisognava andare alla radice dei problemi. “Siamo ormai in tanti ad essere convinti che molti dei problemi dacci siamo angustiati non esisterebbero se, fin dall’inizio, l’Italia avesse avuto un ordinamento ‘federale’”.
La diversità delle aree italiche era stata piallata da uno Stato costruito a modello di quello francese. Il siciliano Francesco Ferrara, già nel 1848, auspicava un’Italia unita “in un patto di volontaria federazione” e non “unificata dalla forza dell’interesse dinastico”. Per l’economista palermitano serviva un equilibrio “tra la forza che dee concentrare e quella che tende a dissipare”, perché il Paese godesse dei benefici dell’indipendenza senza i danni di un’uniformità imposta top down.
Qualche anno dopo, un altro siciliano, Luigi Sturzo, vedeva la crisi della classe dirigente dell’Italia cosiddetta “liberale” intrecciata al fatto che essa lo Stato lo aveva voluto “atomistico, centralizzatore, burocratico”. La sua riorganizzazione su base federalista avrebbe tolto “allo stato una ragione di decadenza politica, di invecchiamento burocratico e di senilità morale”, creando spazi per il pluralismo.
Prediche inutili, come quelle di Miglio. Che pensava che la via verso un autentico federalismo potesse passare dallo spostamento di competenze in capo alle Regioni, che il ceto politico italiano era incline ad accettare (come poi, in effetti, fece). Ma non per fermarsi lì. Le Regioni erano realtà troppo recenti, debole e sguarnite per comporre un ordinamento federale, cioè “una pluralità di comunità politico-amministrative molto indipendenti, ma stabilmente collegate fra loro”. Miglio confidava che, avendo “difficoltà a gestire” le nuove competenze perché “le loro forze e le loro dimensioni sono modeste”, sarebbero state spinte ad aggregarsi, “spontaneamente e per la naturale forza delle cose” in “macro-Regioni” corrispondenti a Nord, Centro e Sud.
Il capitolo sulla “Costituzione economica” di Come cambiare andrebbe riletto oggi, per non perdere la consapevolezza delle conseguenze economiche del sistema partitocratico, molte delle quali ancora con noi. Per Miglio, il modello di una economia mista, divisa fra iniziativa privata e mano pubblica, era stato “snaturato con il prevalere evidente della seconda, e la creazione di un regime e di una società da socialismo reale”.
La distorsione più grave è stata prodotta dalla assuefazione alla lunga prassi dei “trasferimenti”: nella frenetica gara per guadagnare il consenso elettorale, le varie frazioni della classe politica hanno consolidato concordemente l’abitudine di ridurre (apparentemente) il prezzo reale di molteplici beni e servizi goduti dai cittadini (prezzi “politici”), coprendo peraltro tali spese con i profitti dai tributi estorti ai cittadini stessi, o con denaro preso a prestito ancora dai medesimi (debito pubblico).
(…) In tale contesto gli imprenditori, i quali danno lavoro ad un numero rilevante di prestatori d’opera, man mano che le loro aziende sono uscite dal mercato - perché producono beni a costi (e quindi prezzi) anti-economici, o addirittura merci non più richieste - hanno visto la mano pubblica colmare i rispettivi disavanzi, trasferendo denaro, a vario titolo, dalle tasche dei contribuenti a quelle loro e dei loro dipendenti.
(…) Mi sbaglierò, ma ho l’impressione che la difficoltà di vedere ormai l’Italia nell’Europa economica di serie A (se non addirittura in quella di serie B) dipenda da una sotterranea collusione di interessi fra cattivi imprenditori da un lato e frazioni spregiudicate della classe politica dall’altro. I primi si sono accorti di non saper reggere il confronto con la concorrenza d’Oltralpe, e quindi non vorrebbero abbandonare la comoda serra del protezionismo e dell’aiuto pubblico; le seconde si sono accorte che una rigorosa economia di mercato taglierebbe spietatamente le pratiche assistenzialistiche e clientelari da cui dipende la loro legittimazione elettorale.
Nelle pagine di Miglio, così come nel suo impegno politico, c’era la convinzione che le circostanze, il crollo del sistema dei partiti, la fine della guerra fredda, la globalizzazione, l’Europa avrebbero “costretto” l’Italia a cambiare. Sarebbe ingeneroso e miope sostenere che questo non sia avvenuto per niente. Ma i cambiamenti sono stati a spizzichi, disorganici e disordinati, e molti problemi restano irrisolti. Per porre ordine sarebbe opportuno riaprire il dibattito sulle riforme istituzionali, se solo ci fosse qualcuno con la forza (e le idee) per farlo.
Gianfranco Miglio, Come cambiare. Le mie riforme, Mondadori, Milano, 1992, pp. 113.