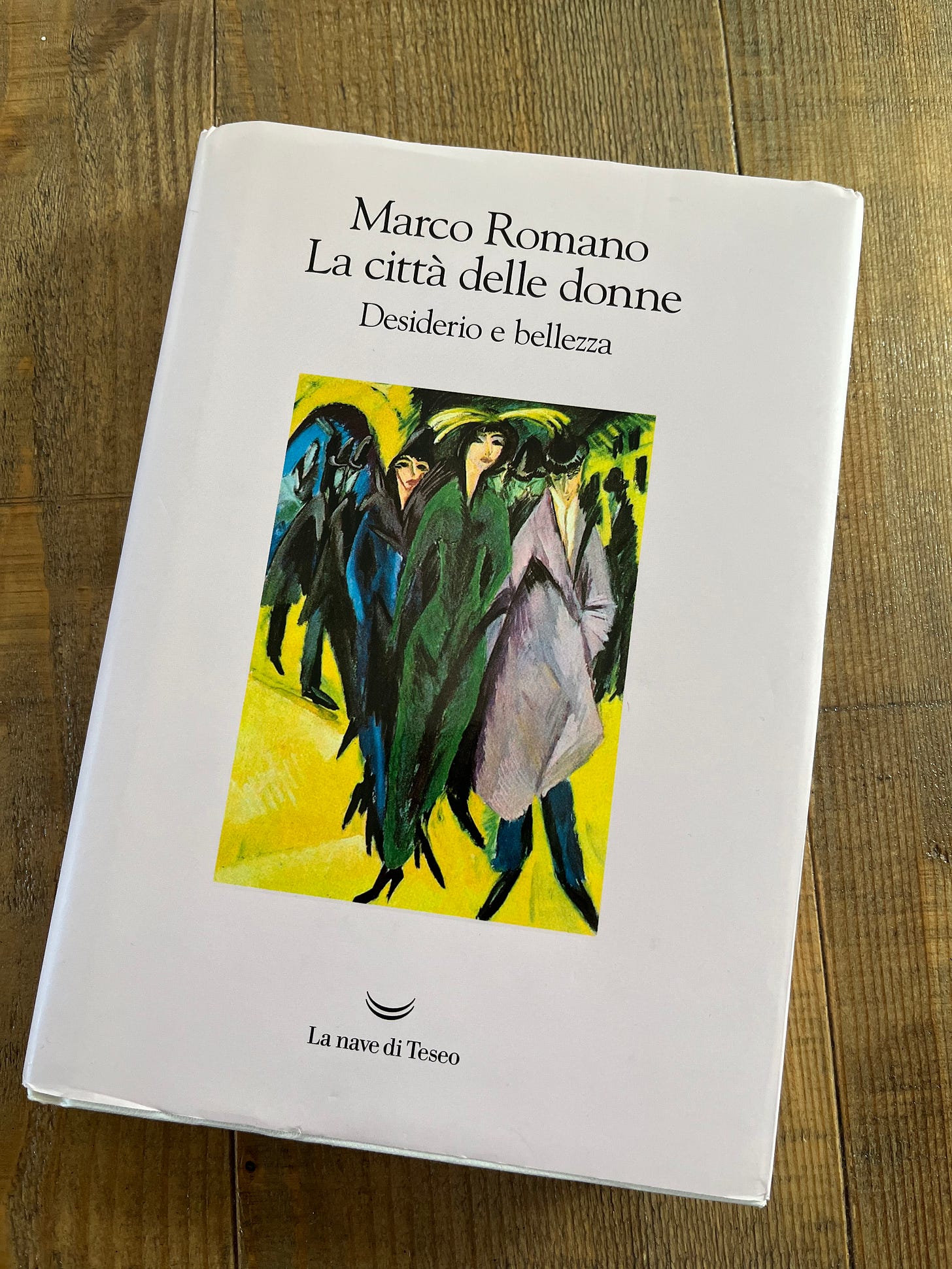Marco Romano ha studiato la città per anni, usandone l’evoluzione per leggere la storia politica europea e anche la storia delle idee. Questo suo libro, pubblicato nel 2019, arrivava dopo la suggestiva raccolta di “ritratti di città” di Le belle città e un saggio importante come Ascesa e declino della città europea. E’ un testo solo apparentemente più leggero, di lettura piacevole, che comincia con un’esaltazione del desiderio come motore dello sviluppo e della città come luogo nel quale gli esseri umani potevano darvi sfogo. Perché, ricorda Romano, alla città si “appartiene” solo perché vi si abita, perché decidiamo cioè di viverci (e si può scegliere di non viverci più), non perché si è venuti al mondo su un certo gradino della scala sociale e da lì non ci si può più muovere.
Noi non apparteniamo con la nascita né a una partizione sociale rigida come quella carolingia, di guerrieri, religiosi o contadini, e neppure alla umma, l’intera comunità del credo islamico. Noi apparteniamo a una civitas la cui espressione visibile è una urbs costituita prima di tutto dalle nostre case, perché da allora condizione essenziale del nostro essere cittadini è di avere il possesso di una casa, tant’è che ancora oggi in Italia a chi si vuole trasferire in un altro comune, uomo o donna che sia, viene chiesto dall’anagrafe dove abita: noi siamo la nostra casa.
In un suo celebre trattato del 1861, Henry Maine aveva sostenuto che “il movimento delle società progressive è stato finora un movimento dallo status verso il contratto” e queste due polarità dovevano servire a Herbert Spencer per tratteggiare la direzione presa dall’evoluzione sociale. Per “status” s’intende quell’insieme di relazioni gerarchiche, verticali, che inchiodavano ciascuno alla stazione nella società dov’era nato. Al contrario il movimento verso la crescente complessità delle relazioni sociali implica l’apertura a legami pattizi, volontari, in cui ciascuno può entrare nella misura in cui sceglie e viene scelto. Ovviamente questo movimento non si compie mai del tutto ma nelle sfumature si possono cogliere i diversi gradi della nostra libertà.
Per Romano si tratta di un processo che potrebbe essere riassunto nella forma “dallo status alla città”. E’ la città che ci spinge fuori dalla dimensione dello status verso quella di legami finalmente spontanei. L’aria della città rendeva liberi, non solo perché in città i servi della gleba fuggiti dalla campagna potevano affrancarsi dal servaggio - ma soprattutto perché quel sommarsi di esseri umani produce iniziative e opportunità.
Queste iniziative e opportunità riflettono i desideri - cangianti, magari fugaci, però proficui - delle persone. Le città sono sfilate di negozi e botteghe dove si compra quel che ci serve per mangiare e quel che ci serve per vestirsi ma, sostiene Romano con Mandeville,
Se si considera un lusso – come a rigore si dovrebbe – ogni cosa che non sia strettamente necessaria a mantenere in vita l’uomo, nel mondo non si troverebbe nulla che non costituisca lusso, neanche tra i selvaggi nudi; anche tra costoro è improbabile che ve ne siano alcuni che non abbiano fatto un qualche progresso rispetto al loro precedente modo di vivere e che, sia nella preparazione dei cibi sia nella sistemazione delle capanne o in altro, non abbiano aggiunto qualcosa a quel che un tempo era loro sufficiente.
Tutte queste cose “non strettamente necessarie a mantenere in vita l’uomo” ne costituiscono l’identità e per Romano la città è dove “la libertà del desiderio e la disponibilità del mercato consente a ciascuno di riconoscere la propria identità, di rispondere alla domanda «chi sono io?»”. Questo quesito però non resta solo all’interno dei negozi e delle botteghe, attraversa le strade su cui si sono disposti, s’impossessa delle facciate delle case (la nostra volontà di essere riconosciuti è anche un vaso di fiori sul davanzale) e diventa, col tempo, un codice che ci consente di mettere le cose al loro posto, di capire dove debbono stare, in quel grande manufatto collettivo che è la città.
Se dunque l’intenzione estetica che plasma ogni aspetto visibile della città ha la sua radice nel desiderio dei cittadini - e in larga misura delle donne - alla ricerca della propria identità nella loro duplice figura di liberi individui e appartenenti alla civitas, abbiamo anche constatato come quel medesimo aspetto visibile sia sempre rinnovato dall’irrompere di nuove espressioni stilistiche fomentate dal medesimo pervasivo desiderio del decoro, e ciò induce alla perentoria affermazione che la città sia tutta intera un’opera d’arte.
In questi anni, c’è una ricetta facile per risultare popolare, perlomeno nella cerchia dei Navigli o nelle “zone ZTL”. Sta nel dire che la città dovrebbe essere meno città, dovrebbe diventare un agglomerato di villaggi dove in quindici minuti ciascuno trovi quello che gli è “necessario”, farsi in qualche modo campagna e magari limitare i nostri consumi ai prodotti degli orti urbani. La città non più come spazio del desiderio, ma come spazio del “bene”, come censore dell’esuberanza individuale, di “lussi” che ormai non pensiamo più debilitino e infiacchiscano ma peggio ancora minacciano l’ambiente. I libri di Marco Romano sono un autentico vaccino contro luoghi comuni oggi ubiqui, potentissimi e liberticidi.
Marco Romano, La città delle donne. Desiderio e bellezza, Milano, La nave di Teseo, 2019, pp. 300