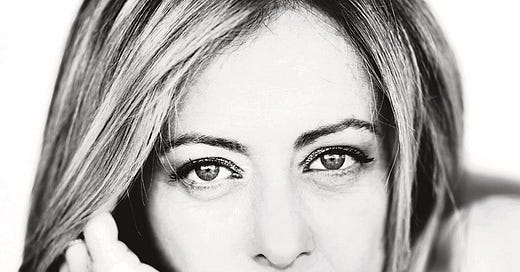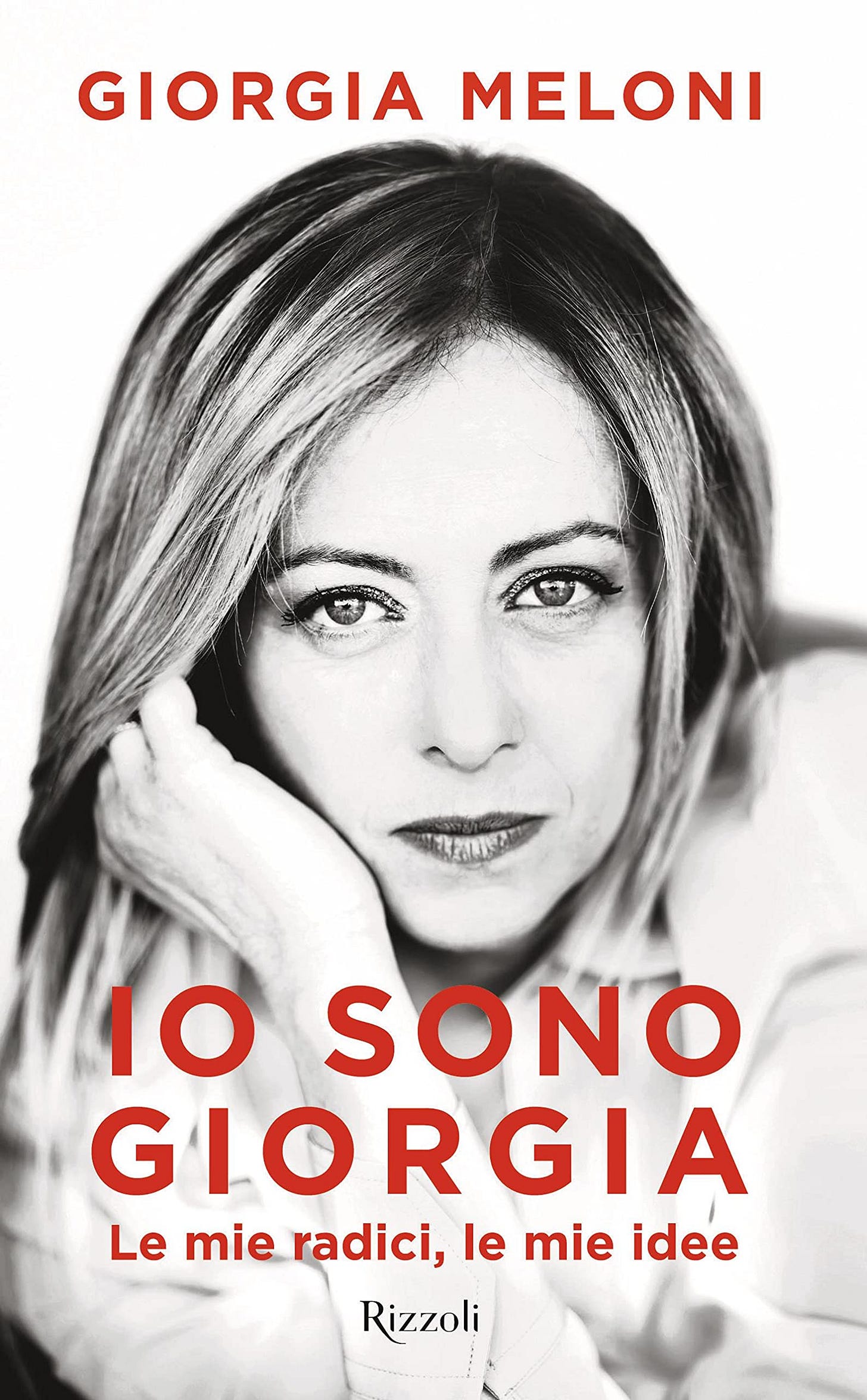Non ho una grande passione per i saggi dei leader politici. E’ difficile, per carità, fare di tutta l’erba un fascio. Ci sono i capi partito (o aspiranti tali) che solo perché si dilettano nel privato di letture di storia scrivono improbabili manifesti per spiegare il mondo, dei guru posticci che scambiano i loro slogan per un pensiero. Ci sono i capi che posano da persone colte, ma cool, e quindi invariabilmente mandano in libreria una loro raccolta di pensierini. C’è il politico colto che ha fatto il professore universitario e che dunque con la pagina scritta dovrebbe avere un po’ più di familiarità ma si diverte, da vent’anni, a offrirci le tesi più funamboliche e apodittiche su come funzionerebbe il mondo, anche se (a parte lui) non se n’è accorto nessuno. C’è qualche onesto politico-giornalista (accoppiata di rigore nella prima repubblica) che svolge con rigore un compitino dignitoso e leggibile.
Insomma, perlopiù si tratta di paccottiglia. Gli editori ci guadagnano perché i politici sono volti noti e in Italia un libro per vendere “sul serio” deve passare per qualche salotto televisivo. I politici col faccione in copertina soddisfano la propria vanità (in questo, non sono in nulla diversi da qualsiasi altro autore di saggi). Il tutto contribuisce a mantenere un manipolo di ghost-writer. Solo che mentre i discorsi di Silvio Berlusconi (riuniti in due volumi) li scrissero don Gianni Baget Bozzo e Giuliano Ferrara e la sua prefazione all’Elogio della follia di Erasmus era scivolata fuori dalla penna di Lucio Colletti, i “fantasmi” su piazza raramente hanno un talento paragonabile, mai una storia accademica o politica simile.
Per questo ho aspettato a leggere Io sono Giorgia, il libro di Giorgia Meloni uscito nel 2021. Probabilmente non l’avrei fatto se Meloni non avesse vinto le elezioni e non fosse, di conseguenza, diventata premier. Avrei sbagliato. Anzitutto, il tomo è ben scritto, piacevole alla lettura, tradisce una voce non perfettamente sovrapponibile a quella dei libri “di cassetta”, fatti con lo stampino. Si tratta in parte di un’autobiografia, in parte di un saggio politico, in parte ancora di un testo programmatico. Non necessariamente le tre cose stanno bene assieme. Il saggio meloniano invece è equilibrato e l’autrice per prima sa collegare ciò che pensa e ciò che le è capitato. Il che è scontato, ma fino a un certo punto: siamo i primi, di solito, a pensare di essere totalmente originali nel nostro pensiero e indipendenti dalle circostanze. In più, Meloni si scopre il giusto, dando valore alle proprie debolezze: l’amore per la figlia Ginevra, il rimpianto per una maternità relativamente tardiva (non, a dire il vero, per gli standard della sua, della nostra generazione), i dubbi su come fare il genitore che le vengono dalla combinazione di una madre affettuosa e molto presente e di un padre che non voleva esserlo e rispetto al quale racconta, senza autocompiacimento e anzi con una sorta di senso di colpa, la propria indifferenza. L’autrice ha il dono dell’autoironia, prende in giro le proprie manie compulsive (a cominciare da quella per l’ordine), offre giudizi politici umani calibrati e ponderati, soprattutto sugli avversari politici. Con due sole eccezioni: Mario Monti e Giorgio Napolitano.
Diversa è la questione quando si tratta di discutere della sua famiglia politica (le radici), espressione forse più accurata che “partito”. E’ normale che un capo politico descriva con generosità le persone con cui ha condiviso anni di militanza, ma di solito si tratta di parole di circostanza o poco più. Non in questo caso. La camaraderie sincera, profonda, viscerale che unisce la leader a coloro con cui ha “rifondato la destra”, dando vita a Fratelli d’Italia, è più evidente a ogni aggettivo. Meloni ne esagera, ma fa parte del gioco, le virtù: da quanti “studiano”, nelle pagine del suo libro, parrebbe che Fratelli d’Italia sia un coacervo di premi Nobel. Ma, iperboli a parte, ciò che si capisce della nostra premier, leggendo Io sono Giorgia, è come interpreti quello che una volta, ai tempi di Gianfranco Fini, si chiamava lo “sdoganamento” della destra. A Fini, per inciso, riconosce grandi errori ma anche un ruolo senza precedenti, nella legittimazione del suo partito. Lei si è caricata sulle spalle il passo successivo: riportare quella comunità politica al governo, accompagnarla finalmente sulla scena con un ruolo di protagonista, evitando di obliare le idee che le hanno dato ossigeno negli anni.
Le idee. Meloni racconta delle proprie esperienze di rappresentanza e di governo, senza omettere qualche episodio gustoso. Ma insiste soprattutto sulle idee. La strada per la legittimazione è, ai suoi occhi, anzitutto culturale. Così, per esempio, si affanna a dimostrarci che i suoi riferimenti nell’ambito della cultura pop non sono poi tanto diversi da quelli dei coetanei di qualsiasi colore politico, solo che - a differenza di quanto capiti a coetanei di altro colore politico - non ha bisogno di offrirne una lettura ideologica per goderne. E’ rinfrancante, diciamo la verità, sapere che la premier descrive se stessa facendo riferimento alle cose che ha letto.
Per portare questa comunità politica che le è cara in un modo che noi, che una comunità politica non ce l’abbiamo, evidentemente non possiamo capire, Meloni tenta anche un aggiornamento del suo armamentario ideale. Chi conosce un po’ la destra italiana sa che non le è mai mancata una cultura “letteraria” ma che l’intersezione dei suoi miti, dalle nostalgie per il ventennio alle suggestioni antiamericane alla convergenza con alcuni elementi della sinistra, la hanno sempre portata lontano da coordinate conservatrici in senso anglosassone. E’ lì invece che Meloni vuole approdare e lo dimostra con l’insistenza con la quale cita Roger Scruton, filosofo e bricoloeur delle idee. Citazioni a parte, Meloni offre della sua destra una definizione che almeno per chi scrive è assolutamente interessante: la parte (prima che il “partito”) del senso della realtà. La destra è “il principio di realtà: il rifiuto di ogni decorazione utopista, di ogni costruzione ideologica”. La destra combatte “per l’uomo concreto che vive nel mondo concreto”.
Per questo, a Meloni riesce di dare una lettura assai persuasiva di quanto avvenuto con il Covid. In un capitolo intitolato “Non è andato tutto bene”, la presidente del consiglio ragiona sulla perdita in termini di libertà individuale (che non abbiamo certamente ancora recuperato in toto) e sul destino dei giovani, sui quali il peso delle restrizioni è stato più elevato anche a fronte del minor beneficio. Sono pagine intense e che in realtà spiegano più di altre il successo di Meloni. Curiosamente, i commentatori hanno raccontato le ultime elezioni come se fossero avvenute senza una pandemia (e le misure di contrasto alla medesima) alle spalle, come se ciò non avesse influenzato il comportamento elettorale né poco né punto.
La cosa meno convincente di tutto il libro è come il principio di realtà venga abbandonato da Meloni in alcuni punti, dove più forte è la capacità di attrazione di idee ben radicate nella destra italiana: a cominciare dal terzomondismo e dall’avversione per la finanza. Per carità, è possibile che quando si scriverà la storia del 2011 essa sarà meno sfavorevole a Berlusconi di quanto non fossero le cronache: ma chiunque avanzi la tesi del “complotto” non può non vedere che è stato un complotto il cui primo cospiratore fu l’ex premier, con i comportamenti e gli errori politici di quei mesi. Meloni abbraccia le grandi istituzioni internazionali e dice che è importante “vedere come ci stiamo dentro”. Giustissimo, ma le pagine anti-austerità rivelano una visione essenzialmente cospiratoria delle politiche europee, poco lontana da quella dei “fanta-keynesiani” di cui, con espressione azzeccatissima, la premier si prende gioco. L’idea che dietro l’immigrazione africana ci stia lo sfruttamento coloniale del continente, e che dunque una sorta di “sovranismo africano” valorizzerebbe al meglio tutte le risorse di quei Paesi accompagnandole all’agognata prosperità, è fumettistica a esser generosi (con rispetto parlando per i fumetti). C’è, sicuramente, qualche elemento di verità ma il problema della povertà è più l’esclusione prolungata dal circuito degli scambi che l’ipotetica eterodirezione degli affari economici da parte di Londra o Parigi. Quel che è peggio, però, è una sorta di ossessione per la “guerra economica” mossaci da altri Paesi europei come Francia e Germania, e la confusione sistematica di chi porta capitale in un Paese (in questo caso, il nostro) con un ipotetico “ladro” di imprese. Di qui discende anche il principio, apparentemente rotondo, che lo Stato “è proprietario e ha il controllo delle infrastrutture strategiche come porti, aeroporti, ferrovie, autostrade, reti di telecomunicazione, reti
idriche, elettriche e digitali. La gestione di queste può poi essere pubblica o privata”. Al di là di qualsiasi altra considerazione (che cosa sono le reti “digitali” se sono altra cosa dalle reti di telecomunicazione?), fa un po’ sorridere che il commento arrivi poche righe dopo una considerazione abrasiva sulla tragedia del Ponte Morandi. Le autostrade sono rimaste pubbliche, è la loro gestione che, col regime concessorio, era affidata a un privato, ora semi-nazionalizzato.
Meloni definisce Fratelli d’Italia come un partito “produttivista”, scrive che chi fa impresa in Italia “è un eroe, a maggior ragione dopo il cataclisma Covid”, ricorda che la ricchezza la creano le imprese e non lo Stato. Per chi ha qualche familiarità con gli ambienti culturali da cui viene parte della destra italiana, sono passi in avanti molto significativi. Continua a mancare, in questo libro, un’adesione alla cultura della concorrenza e in parte anche della prudenza della finanza pubblica - quest’ultima, provvidenzialmente recuperata in campagna elettorale. Se lo scrivo, non è per indulgere all’abitudine (sono d’accordo con Meloni, odiosa) di dire alla destra ciò che la destra dovrebbe essere e fare. Ma perché sarebbe perfettamente coerente con il “principio di realtà” che è cardine del suo essere “di destra”.
Ovviamente, non si può pretendere che in un libro un leader si rimangi o riveda sostanzialmente cose che ha detto per anni in trasmissioni Tv e comizi. Fratelli d’Italia nasce contro la presunta austerità del governo Monti, e quell’imprinting rimane. Ma questo è un libro che restituisce un’umanità e una dimensione anche intellettuale non posticce, e per questo spiace non trovarci cose che, a chi scrive almeno, pare ci sarebbero state bene.
Giorgia Meloni, Io sono Giorgia. Le mie radici le mie idee, Mondadori, Milano, 2021, pp. 336.