Uscito nel 1966 su ABC, questo dissacrante manualetto di Luciano Bianciardi a uso dell’aspirante intellettuale andrebbe in realtà consigliato soprattutto ai pochi lettori di giornali sopravvissuti. Che lo tengano a portata di mano, a pochi centimetri dalla postazione dove usualmente si accomodano per sfogliare il quotidiano di carta o scorrerlo sull’iPad. E, di tanto in tanto, tornino a queste pagine, magari dopo aver scorso il menù dei supplementi culturali, o dopo l’articolo di fondo che riassume con rotonda sintesi il pensiero comune delle persone ben informate sull’alluvione in Emilia Romagna o sugli esiti dell’ultimo G7. “Pensiero” veloce, sistemazione in bella prosa di ciò che il lettore già pensa e a veder bene non può non pensare.
Bianciardi mette in chiaro che il suo manualetto non serve per chi voglia diventare giornalista: che è già troppo lavoro. Immagina invece uno sfaccendato senza grande talento, proveniente dal “ceto medio e spesso mediocre”, dov’è “più probabile che si reclutino gli intellettuali di domani”. Un “diplomato con la media del 7” che ha “l’impressione di essere in regola coi programmi, cioè di sapere tutto”, il quale “non sa scrivere e neanche ne ha voglia” ma vuole “arrivare”. Quest’arrivare ha per meta un mondo di mezzo, né politica né impresa, l’ “impresa culturale” che poi è un sottobosco di “posti” e vetrine ai quali si accede per un’abilità particolarissima: costruire, attorno a se stessi, un alone di mistero, una piccola mitologia.
Bianciardi suggerisce alla sua ideale Eliza Doolittle, che viene dalla provincia, di diventare vicepresidente di un circolo culturale. Non Presidente, carica destinata a qualche “trombone locale desideroso di mettersi in mostra”, e nemmeno segretario o direttore, che è “quello che sgobba e leva le castagne dalla padella bucata”. Il vicepresidente ha funzioni eminentemente cerimoniali, va a ricevere “l’illustre ospite venuto dalla grande città”, lo riconosce alla stazione vuoi perché ne ha cercato da qualche parte una fotografia vuoi perché “le sembianze di chi arriva per parlare in pubblico sono inequivocabili”, fa la scena di comprare naturalmente “una seconda” copia del suo libro chiedendo la dedica per un’amica, facendo tutto quel che deve affinché l’autore non se ne dimentichi e anzi ne racconti in giro. “In provincia si legge con estrema attenzione, si ha rispetto autentico per la letteratura, c’è persino un pubblico femminile che sta formandosi”.
Questo “manuale di stile” non ha come ideali interlocutori persone che sentano di avere qualcosa da dire, avverte di stare ben attenti a non pencolare a destra o a manca, fornisce abbondanza di frasi fatte da usare con l’obiettivo di sembrare “così intelligente” e di incassare la piccola rendita che ne può venire. Bianciardi aveva frequentato case editrici e giornali e non ne racconta nessuno in particolare ma li racconta tutti. La superficialità tronfia, l’infantilismo finto colto che descrive in modo così esilarante sono ancora con noi, sessant’anni dopo, e definiscono tratti molto comuni nella modesta piazza cultural-letteraria italiana, dove non c’è un intellettuale degno di questo nome che non sappia sciorinare, salottiero e sornione, nomi dei suoi colleghi e appunti molto precisi sulle loro abitudini sessuali (“si dichiari tollerante verso i costumi sessuali altri, specialmente quelli dei negri, degli svedesi e degli americani. Sia all’opposto severo se il discorso cade sul prossimo più immediato”), eno-gastronomiche o igieniche, ma è dura cavargli di bocca un commento non precotto su un saggio o un romanzo. “E’ il suo libro migliore”. “Si veda che l’ha scritto di fretta”. “E’ solo un pamphlet”.
qual è l’accusa più frequente che muovono i letterati al collega appena appena più prolifico di loro? «Scrive troppo», dicono. «E’ un poligrafo.» Parrà strano, ma nel mondo delle lettere il peggior peccato di uno scrittore consiste nello scrivere. Il Nostro se ne asterrà, per quanto possibile: un pezzo di colore esotico a vent’anni, una cauta recensione a venticinque, a trenta, già intellettuale di successo, “curerà” i libri, evitando di scriverli o di tradurli. Due paginette di prefazione, tanto per mettere le mani avanti, mai elogiative, anzi limitatorie («presentiamo qui raccolti alcuni scritti, minori ma significativi, pur nei loro limiti, nell’onesta traduzione di Gerolamo Traslati…»). Se il libro andrà bene, suo il merito. Nel caso contrario, ci vuole assai poco a dare la colpa a chi ha lavorato. Se l’ammalato dovesse morire, si può, in coscienza, dare la colpa al “curatore”?
Leggere queste pagine, fra l’altro divertentissime, ci costringe a fare i conti con le nostre quotidiane ipocrisie. E’ vero che giornalismo e “cultura” contemporanei offrono un campionario di stilemi diversi, ma forse non sono poi così lontani dall’essere variazioni sui temi di Bianciardi. Tutti assieme disegnano le precondizioni del conformismo che caratterizza proprio coloro che, in teoria, dovrebbero avere massimamente cara la libertà di pensiero. Anche quella, meglio farsela raccontare.
Luciano Biancardi, Non leggete i libri, fateveli raccontare (1966), Vicenza, Neri Pozza, 2022, pp. 112.




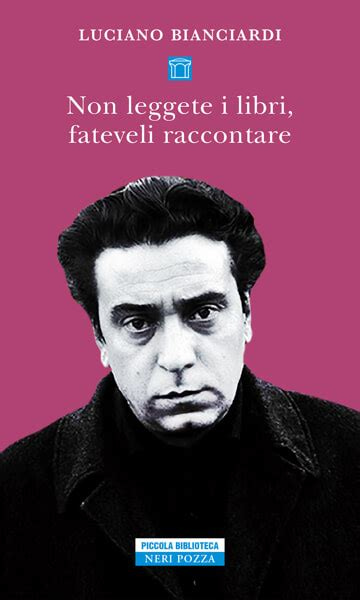
Mi vengono in mente tanti nomi, ma non posso farli, ché certi intellettuali sono molto suscettibili e hanno la querela facile...