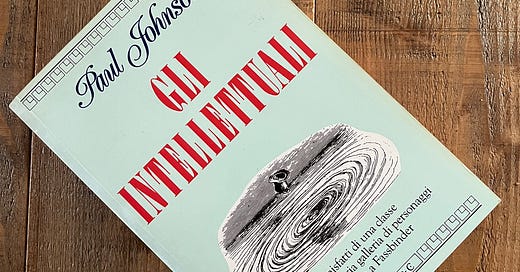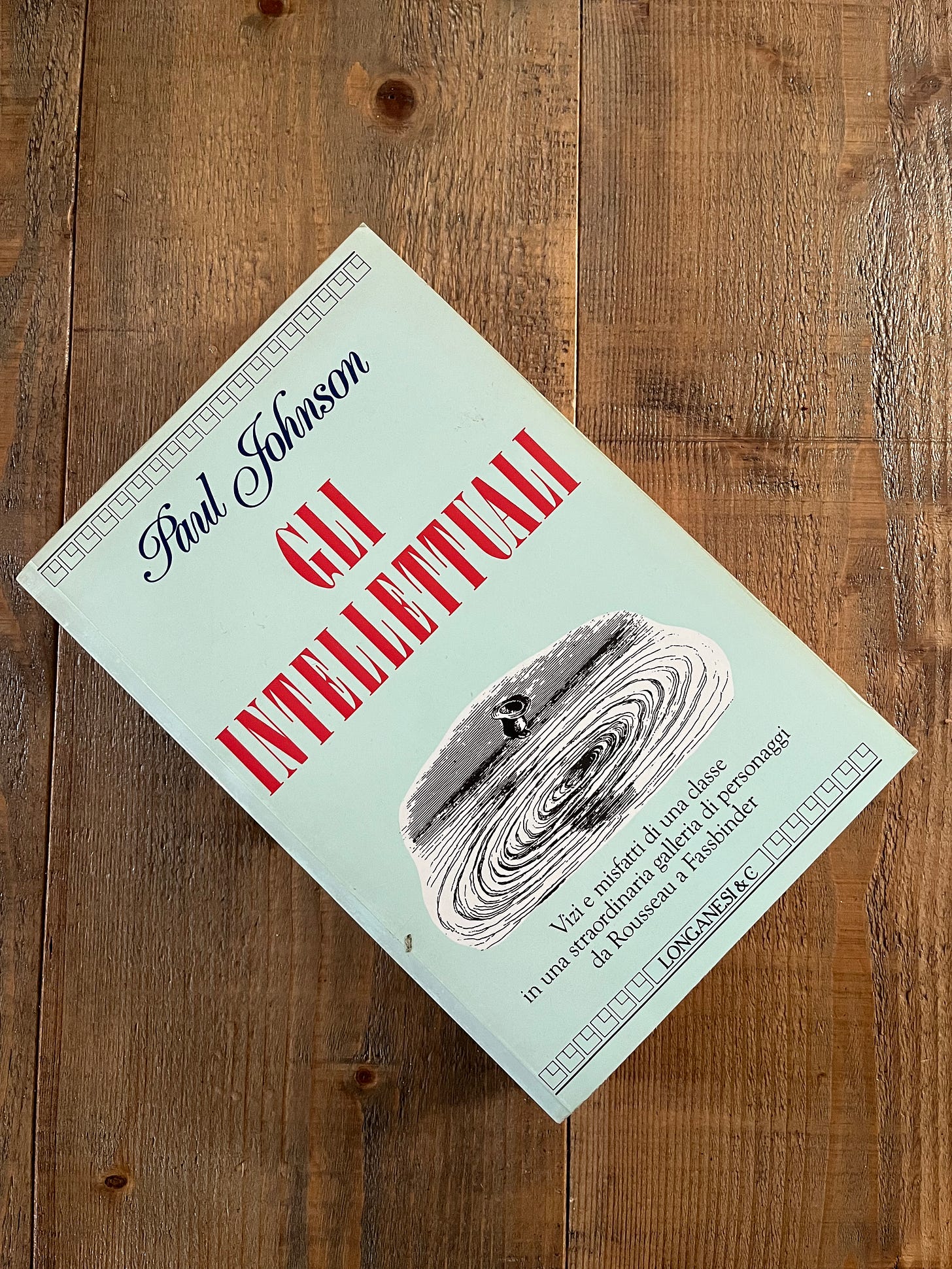Paul Johnson (1928-2023) è morto qualche giorno fa. Theodore Dalrymple (Anthony Daniels) e John Fund, fra gli altri, hanno raccontato un grande maestro del giornalismo e un pensatore che ha segnato il conservatorismo contemporaneo. Fund, in particolare, ricorda l’impatto di Modern Times (tradotto anche in italiano, Storia del mondo moderno, Mondadori), un’opera di straordinaria erudizione con cui Johnson rilesse la storia del Novecento.
Negli ultimi anni, Johnson scrisse una serie di biografie, da Napoleone a Charles Darwin, eccellenti lavori di divulgazione ma senza lo smalto dei suoi saggi degli anni Ottanta e Novanta, nei quali univa una capacità straordinaria di farsi capire con prospettive originali e spesso del tutto inedite, almeno per il grande pubblico che riusciva a raggiungere. E’ il caso di The Intellectuals, Gli intellettuali, un libro del 1987 che raccoglie una serie di ritratti di uomini di pensiero: da Jean-Jacques Rousseau a Werner Fassbinder. Johnson fa due operazioni diverse assieme. Da una parte, svela le ipocrisie che dominano la vita degli intellettuali moderni. Di Rousseau ricorda implacabilmente come non fosse proprio disinteressato ai quattrini, come pretendeva e come avrebbe dovuto essere per un minimo di coerenza col proprio pensiero, e come abbandonò cinque figli. Uomo di prodigiosa memoria e grafomane irrefrenabile, delle creature non annotò nemmeno la data di nascita. Di Ibsen, Johnson racconta quanto fosse del tutto incapace di coltivare relazioni d’amicizia. Di Marx, in realtà il modello sul quale si sono misurati tutti gli intellettuali successivi, nota come “il suo perenne stato di irritazione, le abitudini dittatoriali e la costante amarezza riflettevano senza dubbio la giustificata consapevolezza di possedere grandi capacità e la frustrazione di non poterle esercitare più efficacemente”. Che è poi, senza essere Marx, convinzione granitica di ogni intellettuale, presente incluso.
Il suo rabbioso egoismo aveva radici fisiche oltre che psicologiche. Marx conduceva una vita particolarmente malsana: faceva pochissimo esercizio fisico, mangiava cibi molto conditi, spesso in grande quantità, fumava molto, beveva molto, specialmente birra ad alta gradazione, e il suo fegato ne risentiva. Faceva il bagno raramente e in genere non si lavava molto: questo potrebbe spiegare, insieme alla dieta poco sana, la vera e propria piaga dei foruncoli della quale soffrì per un quarto di secolo e che, naturalmente, accresceva la sua irritabilità; sembra che ne soffrisse in maniera particolarmente acuta mentre era impegnato a scrivere il Capitale. «Qualsiasi cosa succeda», scriveva a Engels di malumore, «spero che la borghesia si ricorderà sempre dei miei foruncoli».
Sui contemporanei, gli aneddoti sono ancora più ghiotti. Sartre, ad esempio
Parlava anche quando nessuno lo stava ad ascoltare. L’autobiografia del regista John Huston contiene un gustoso ritratto di Sartre, che era stato suo ospite in Irlanda nel 1958-59, quando lavoravano insieme alla sceneggiatura per un film su Freud. Così Huston descrive il filosofo francese: «Un barilotto d’uomo, brutto come il peccato, la faccia gonfia e butterata, i denti giallastri, gli occhi strabici». Ma il suo fatto più peculiare era che «non sapeva cosa volesse dire conversare. Parlava senza mai smettere. Impossibile interromperlo. Uno aspettava che si fermasse per riprendere fiato: e invece no. Le parole gli sgorgavano dalla bocca come un torrente ininterrotto». Huston rimase esterrefatto nel vedere che di tanto in tanto, mentre parlava, si fermava per annotare le sue stesse frasi. E se, incapace di reggere a quel profluvio di parole, usciva dalla stanza, il ronzio della voce di Sartre lo accompagna per tutta la casa; e al suo ritorno Sartre era ancora lì che parlava.
Ma The Intellectuals non è solo una collezione di maldicenze, per quanto godibili possano risultare al lettore. Johnson usa la costante discrasia fra prediche degli intellettuali e le loro azioni per farci riflettere su come occuparsi dell’umanità “all’ingrosso” si riveli spesso una scusa per non occuparsene al dettaglio. Essere impegnati a salvare il mondo è un’eccellente alternativa a curarci del nostro prossimo in carne e ossa. Che, per carità, molto spesso è un parente molesto o un vicino di casa rumoroso. E tuttavia è una persona coi suoi dolori e i suoi problemi, per la quale un aiuto concreto o una parola buona possono fare la differenza.
Alla luce di tutto ciò non è poi sorprendente che gli intellettuali tendano a considerare positivamente la violenza politica. Magari, anche in questo caso, con due pesi e due misure: elogiando quella degli amici e biasimando quella dei nemici, ma spesso desiderando l’intervento salvifico di uno o più “uomini forti”, per rimettere a posto le troppe ingiustizie del mondo. Sempre all’ingrosso: milioni di individui visti come creta da modellare a piacimento, anche con le cattive se necessario.
Sono quasi degli automatismi: l’intellettuale tende a pensare che il mondo non è quel che appare all’osservazione e al senso comune, la realtà deve essere spiegata da qualche principio che ai più sfugge ma che da solo può rivelare la catena d’ingiustizie che si cela dietro la scena degli eventi. Accogliere questa conoscenza, che la maggior parte delle persone magari non riuscirà mai a comprendere (meglio ancora, quale più evidente conferma del suo valore?), è solo il primo passo. Dopo, verrà il momento di far collassare il mondo delle apparenze, di smontare le quinte del male e di ricostruire una realtà totalmente diversa. Tutto ciò prende la forma di parole generose ma anche di mezzi efferati. E che diamine, quando c’è un pianeta da salvare volete che il fine non giustifichi i mezzi?
Vale la pena riportare la conclusione del libro di Johnson, la morale delle tante storie che racconta:
una delle lezioni più importanti di questo nostro tragico secolo, che ha visto tanti milioni di vite innocenti sacrificate a questo o quel progetto per migliorare i destini dell’umanità, è «guardiamoci dagli intellettuali». Non solo bisognerebbe tenerli lontani dalle leve del potere, ma andrebbero guardati con particolare sospetto quando pretendono di impartire consigli alla collettività. (…) Sopra ogni altra cosa, dobbiamo tenere presente sempre quello che gli intellettuali abitualmente dimenticano: che le persone contano di più delle idee astratte e devono avere la priorità. Il peggiore di tutti i dispotismi è la spietata tirannia delle idee.
Paul Johnson, Gli intellettuali (1987), Longanesi, Milano, 1990, pp. 473.