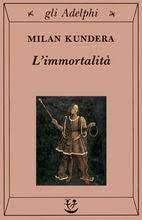Sul Foglio, giovedì scorso, in un breve pezzo in morte di Milan Kundera, citavo quello che secondo me è un libro capitale, La vita è altrove, più utile di mille trattati per comprendere le torsioni intellettuali del nazionalismo, la retorica della “lotta” e lo spirito degli “intellettuali” che per un secolo hanno pensato di battere il tempo alla politica.
Qui mi piacerebbe ricordare invece un suo romanzo ben più recente, scritto in francese e non in ceco (il mondo è pieno di gente che sostiene che il Kundera che scrive in francese non è più quello di una volta, a me questa versatilità linguistica pareva già straordinaria di per sé), L’immortalità. Che è legato a La vita è altrove da tutta una serie di incastri. Nella terza parte del libro (che è diviso in sette sezioni), ci sono pagine quasi profetiche.
La realtà, scrive Kundera, ha sconfitto l’ideologia:
I comunisti (…) credevano che con lo sviluppo del capitalismo il proletariato sarebbe diventato sempre più povero, e quando un giorno fu dimostrato che gli operai in tutta Europa andavano al lavoro in macchina, essi sentirono una gran voglia di gridare che la realtà bastava.
E fin qui. Ci mancherebbe che certe cose non le sapesse uno scrittore che aveva attraversato la parabola del socialismo reale e ne aveva i segni sulla propria pelle.
Il problema, aggiunge Kundera, è che ormai c’è qualcosa che batte anche la realtà.
E proprio perché ormai da tempo ciò che è rimasto di Marx non costituisce più un sistema logico di idee, bensì unicamente una serie di immagini e di slogan suggestivi (l’operaio che sorride impugnando il martello, il negro, il bianco e il giallo che si tengono fraternamente per mano, la colomba della pace che spicca il volo verso il cielo, eccetera, eccetera), a buon diritto possiamo parlare di una graduale e planetaria trasformazione dell’ideologia in imagologia.
Non che al potere sia mai sfuggita l’importanza dell’immagine (quell’immagine sulla quale lavoriamo alacremente e che pure resta “il nostro più grande mistero”), del simbolo, della “frase breve che diventa di colpo famosa”. Ma nel mondo contemporaneo immagini e simboli riescono con facilità nuova a conquistare il dominio sulle nostre vite. L’immortalità è del 1988, quando l’espressione “rete sociale” aveva tutt’altro significato. Suggeriva però che qualcosa fosse già cambiato, nel nostro modo di vivere. La realtà
da molto tempo ha smesso di essere per l’uomo quello che era per mia nonna, la quale viveva in un paese della Moravia e conosceva ancora tutto per esperienza personale: come si cuoce il pane, come si costruisce una casa, come si uccide il maiale, come si fa affumicare la carne, come si imbottiscono i piumini, che cosa pensavano del mondo il parrocco e il maestro; ogni giorno incontrava tutto il villaggio e sapeva quanti omicidi erano stati commessi nei dintorni da dieci anni a questa parte; aveva, per così dire, un controllo personale sulla realtà, cosicché nessuno poteva darle a bere che l’agricoltura in Moravia era fiorente se in casa non c’era da mangiare. A Parigi, il mio vicino passa il suo tempo in un ufficio, dove siede per otto ore di fronte a un altro impiegato, poi monta in macchina, torna a casa, accende la televisione e quando l’annunciatore lo informa che secondo un sondaggio d’opinione la maggioranza dei francesi ha deciso che la Francia è il paese più sicuro d’Europa (…) per la gioia apre una bottiglia di champagne, e non saprà mai che proprio quel giorno nella sua strada sono stati commessi tre furti e due omicidi.
E’ chiaro che è un grandissimo vantaggio poter usare strumenti e godere di beni il cui funzionamento ci è misterioso: come il computer col quale ho ricopiato la citazione di Kundera. In un certo senso, più sono le cose che non possiamo capire e che pure possiamo utilizzare, e più stiamo bene, più siamo ricchi, più sono le necessità e i bisogni che riusciamo a soddisfare. Ma in qualche modo dovremmo esserne meravigliati, e curiosi, e considerarli una sorta di miracolo che la cooperazione di altri esseri umani ci ha reso disponibile. Bisognerebbe anche praticare l’arte di sospendere il giudizio, di non pensare che possiamo squadernare secondo il nostro gusto le condizioni nelle quali manufatti così miracolosi vengono realizzati, che basti un tratto di penna, estrarre dal cilindro qualche parola rotonda (“transizione”), molti soldi (possibilmente presi in prestito dai nostri nipoti), per rifare, e per giunta meglio, un mondo che non comprendiamo. Lo svolgere mansioni che sono più lontane dalla concretezza “materiale” non dovrebbe autorizzarci a ignorarla, o considerarla irrilevante.
Invece praticamente tutto il dibattito pubblico (usiamo l’espressione per capirci, ma purtroppo un dibattito pubblico degno di questo nome chissà da quanto non c’è più, e sicuramente non è esistito negli ultimi tre anni) è fatto di immagini. Poderose. Di racconti semplificati. Di storie di cappa e spada in cui nulla è precluso né mai potrebbe esserlo, ai “buoni”.
Gli imagologi creano sistemi di ideali e anti-ideali, sistemi che hanno breve durata e ognuno dei quali viene rapidamente sostituito da un altro, ma che influenzano il nostro comportamento, le nostre opinioni politiche e il nostro gusto estetico, il colore dei tappeti e la scelta dei libri, con la stessa forza con cui un tempi riuscivano a dominarci i sistemi degli ideologi.
Gli imagologi dominano e hanno cancellato le sfumature, l’accettazione se non la tolleranza delle imperfezioni, il dubbio, l’umiltà intellettuale dal panorama. Il guaio è che il dominio di immagini e story telling non ci ammansisce. Direi che anche ci rende tutti più intolleranti, forse anche più pericolosi.
Milan Kundera, L’immortalità (1988), Milano, Adelphi, 1993, pp. 366.