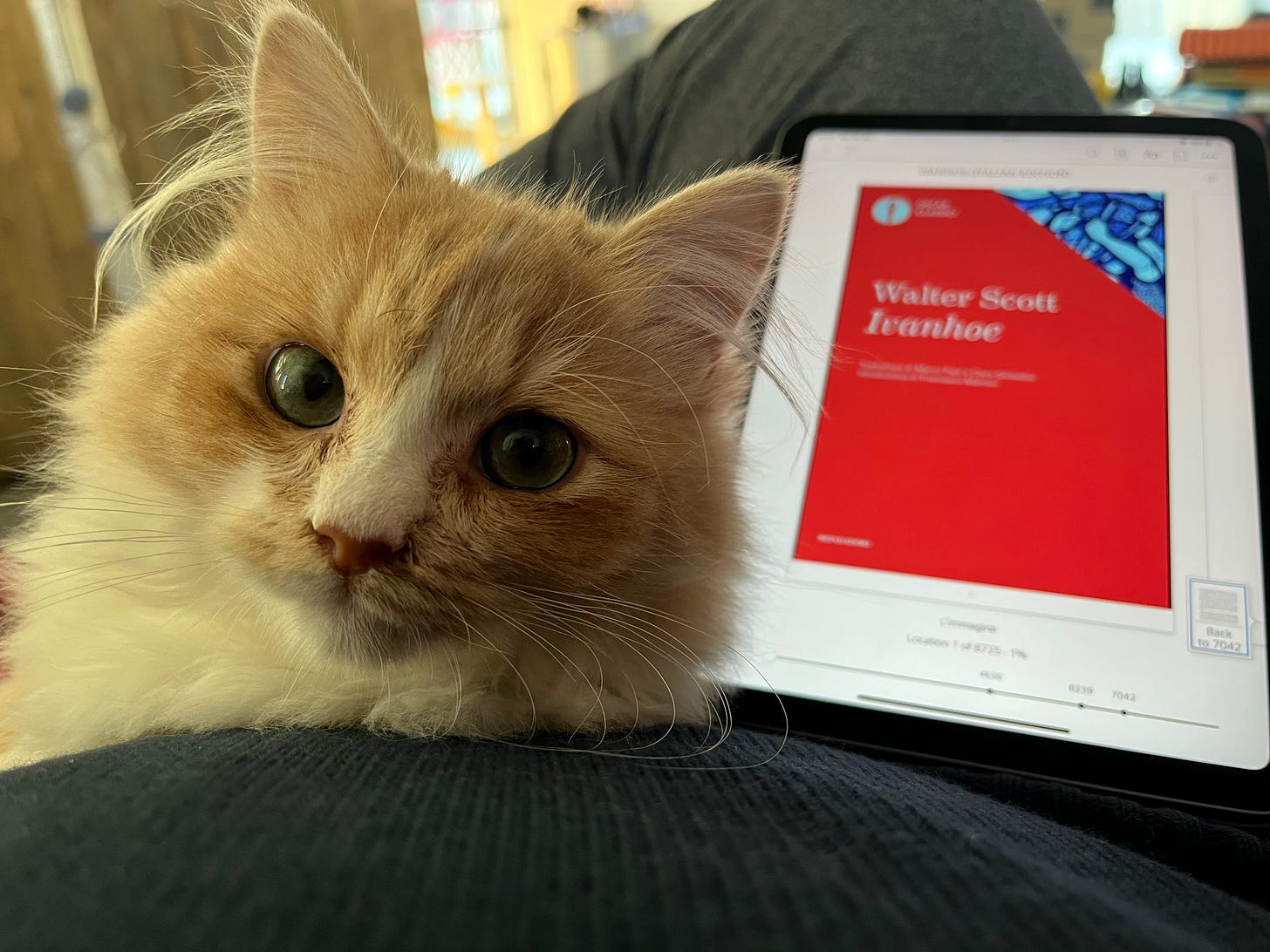Ricordo di averlo visto per la prima volta, da bambino, nel salotto di mia nonna. Quell’edizione risaliva con tutta probabilità all’infanzia di mio padre, e anche per questo mi guardai bene dall’aprirla. Vista la copertina, pensai fosse un libro per bambini: da adolescenti siamo di solito particolarmente cretini (così almeno ero io).
Il lato positivo è che mi è rimasto il gusto di leggere Ivanhoe da adulto. Ed è una meraviglia, c’è poco da fare. Per noi che siamo cresciuti con il film d’animazione di Walt Disney, c’è anzitutto il piacere di ritrovare al completo il cast di Robin Hood. La stessa scena del cartone nella quale un Robin Hood travestito da cicogna vince il torneo di tiro con l’arco, mentre l’orso Little John travestito da sir Reginald, duca di Whisky, intrattiene il principe Giovanni, è un omaggio a Scott. Averlo saputo prima!
Ma in questo romanzo storico c’è molto di più. A dispetto delle apparenze e degli anni in cui ebbe fortuna, Ivanhoe non è un’avventura “romantica”, anzi.
I temi principali del romanzo sono tre.
In primo luogo la difficile convivenza fra un popolo di conquistatori e un popolo di conquistati: è il “giogo normanno”, mito politico assai caro al radicalismo inglese, che Scott prende per buono ma fino a una certo punto (egli suggerisce che vi sia stata una “progressiva fusione sociale” fra i due popoli, della quale i matrimoni misti, incluso quello con cui il romanzo si conclude, sono un simbolo).
Infatti il secondo tema è quanto possano sopravvivere alcune tradizioni e alcuni modi di essere dopo aver fatto il proprio tempo. I sassoni potranno pure vantare legittimi diritti che i normanni hanno calpestato, ma alcune delle loro istanze e tradizioni sono obsolete, debbono accettare che la storia ha fatto il suo corso.
Il terzo tema è la tolleranza. La vicenda di Rebecca, la cui bellezza tira fuori il peggio dal templare Brian de Bois-Guilbert, ma anche qualcosa di buono, voleva parlare ai suoi lettori dei diffusi pregiudizi sugli ebrei. Scott lo fa con levità, incastonandoli perfettamente nella storia, facendone persino dei momenti comici. Eppure il “messaggio”, in questo caso, è inequivocabile. Persino le crociate non sono state che un’occasione d’oro per pellegrini ipocriti e per qualche cavaliere che, dopo essersi fatto il segno di croce, è corso a insozzarsi di sangue, dicendo così di fare la volontà di Dio.
In questa storia di cavalieri e dame, Scott ci mostra i cavalieri (che abbiano fatto o meno le crociate) tendenzialmente come dei fanfaroni che sono nobili di nascita ma non di spirito. I suoi templari sono una banda di invasati e fra di loro i fanatici sono di gran lunga più meschini dei peccatori. I sassoni avranno tutte le ragioni dalla loro, ma si perdono in fantasticherie anacronistiche e finiscono per esagerare la loro stessa oppressione.
Gli eroi di Scott, insomma, non sono certo personaggi di cartone e l’impressione del lettore è che egli avesse ben chiara la lezione degli illuministi scozzesi, a cominciare da alcune pagine della Teoria dei sentimenti morali di Adam Smith. Forse proprio per questo carattere anti-eroico il libro piacque a György Lukács, che ne diede invece una lettura quasi marxista, e a Ho Chi Minh, che lo considerava il suo romanzo preferito. Stesso giudizio diede Tony Blair, durante la campagna elettorale che lo vide sconfiggere il povero John Major. Forse, in quel caso, l’obiettivo del furbissimo Blair era strizzare l’occhiolino al patriottismo degli elettori conservatori (Major indicò invece come suo autore preferito il grande Anthony Trollope).
Ivanhoe è, si direbbe oggi, un page-turner. Il lettore viene tarantolato in un intreccio così avvincente che delle questioni di cui abbiamo sinteticamente detto neppure si avvede, dovrà ripensarci poi. Del resto, i grandi scrittori sono precisamente quelli che non si affacciano a un pulpito e non ne sentono il bisogno.
Walter Scott, Ivanhoe (1819), Milano, Mondadori, 2017, pp. 670